Introduzione a Écrits Révisionnistes (1974-1998)
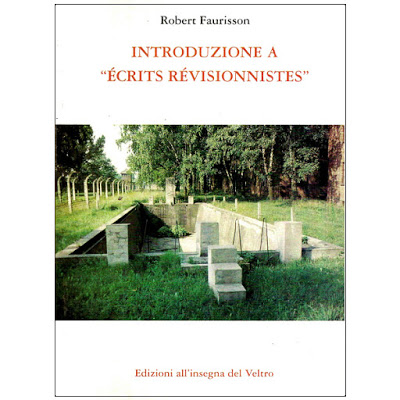
Scritti revisionisti (1974-1998)
Con questo titolo Robert Faurisson pubblica, in quattro volumi, un’opera di più di duemila pagine che raccoglie articoli, saggi, studi, recensioni e lettere che egli ha redatto in venticinque anni di battaglia per la storia. Alcuni di questi scritti sono già stati pubblicati, qua e là, nel corso degli anni; la maggior parte è circolata solo come samizdat oppure è totalmente inedita.
L’opera esce in edizione privata, fuori commercio e senza indicazione di prezzo. Infatti, le leggi francesi sulla libertà di stampa (sic) e, in particolare, la legge Fabius-Gayssot, vietano la diffusione pubblica di scritti contrari a certe verità concernenti la storia della seconda guerra mondiale.
Nonostante la repressione che si è abbattuta, in Francia e all’estero, sui revisionisti, Robert Faurisson ha persistito nel voler far sentire la sua voce nella più viva controversia storica del nostro tempo.
Robert Faurisson, nato nel 1929, agrégé des lettres, dottore in lettere e scienze umane, professore all’università di Lyon-II, fu privato della sua cattedra nel 1990 per decisione ministeriale non motivata.
___________
Il testo della presente Introduzione è disponibile in formato cartaceo (76 pagine, €15) presso Edizione all’insegna del Veltro, Viale Osacca 13 – 43100 Parma – edizioni@insegnadelveltro.it.
***
In Memoriam
La consuetudine vorrebbe che in capo a questi Écrits révisionnistes io ringraziassi, senza distinzione, tutti coloro che mi sono venuti in aiuto nelle mie ricerche o nella realizzazione dell’opera.
Contrariamente a questa consuetudine, mi asterrò dal nominare qui i vivi e non nominerò che i morti.
In un periodo in cui designare un revisionista con il suo nome equivale in qualche modo a denunciarlo alla polizia del pensiero o alla muta dei media ed esporlo così al rischio di perquisizioni, sequestri, disoccupazione, ammende o prigione, si comprenderà che non posso, in coscienza, dedicare la presente opera a nessuno né a nessuna di coloro che meriterebbero che io esprimessi loro pubblicamente, mentre sono vivi, la mia gratitudine o la mia ammirazione.
Della coorte di morti che suggella il revisionismo io non ricorderò qui che qualche nome sotto la cui ispirazione io ho, per un quarto di secolo, vissuto l’avventura del revisionismo storico e a cui vorrei esprimere la mia riconoscenza postuma: Jean Norton Cru (per la prima guerra mondiale), Paul Rassinier, Maurice Bardèche, Louis-Ferdinand Céline, Albert Paraz, Jean Genet* e François Duprat. A questi nomi aggiungerò, per la Francia, quelli di Jean Beaufret e di Michel de Boüard; per l’Austria, quello di Franz Scheidl; per la Germania, quello di Hellmut Diwald e, per gli Stati Uniti, quello di James Morgan Read, il primo storico al mondo che si sia interrogato sulla realtà delle pretese camere a gas naziste, e questo già nel mese di maggio del 1945, e al contempo d’altronde – puro incontro di grandi spiriti – l’Inglese George Orwell.
Io dedico anche queste pagine al Tedesco Reinhold Elstner che, a Monaco il 25 aprile 1995, si è immolato dandosi fuoco in segno di protesta contro il «Niagara di menzogne» riversato sul suo popolo; la polizia tedesca ha, in base a degli ordini, confiscato i mazzi di fiori deposti sul luogo del sacrificio e proceduto a fermare coloro che, con questo gesto di compassione, testimoniavano la propria sofferenza.
A rischio di essere mal compreso da alcuni, dedico anche quest’opera a coloro, tra i vincitori macchiati di sangue della seconda guerra mondiale, che, come Churchill, Eisenhower o de Gaulle, hanno rifiutato, sia durante che dopo la battaglia, di avallare, non fosse che con una parola, l’atroce, grottesca, insolente impostura del preteso genocidio degli ebrei e delle pretese camere a gas naziste.
Auspico infine che la presente opera possa iscriversi nel segno di una memoria, non selettiva e tribale, bensì universale, senza esclusiva alcuna: in memoriam omnium. Possa essa leggersi anche come un omaggio alle vere sofferenze di tutte le vittime della guerra 1939-1945, siano queste vittime appartenute al campo dei vincitori, che sono incensati, o a quello dei vinti, che non si smette, da quasi mezzo secolo, di umiliare ed offendere.
________________
* Non se ne dispiacciano i mani di Jean-Paul Sartre, Jean Genet non credeva al genocidio degli ebrei; egli vi vedeva addirittura un’impostura. Per lui, «il popolo ebraico […] ha fatto credere al genocidio» e lo Stato d’Israele ha il comportamento di un «demente tra le nazioni» (“Quatre heures à Chatila”; i brani censurati da La Revue d’études palestiniennes si ritrovano in L’Ennemi déclaré, Gallimard, Parigi 1991, p. 408, n. 30).
***
INTRODUZIONE A
ÉCRITS RÉVISIONNISTES (1974-1998)
Non è un revisionista che lo afferma bensì un antirevisionista:
«Negatore dell’Olocausto», «revisionista», «negazionista», tutti sanno che cosa significano tali rimproveri. L’esclusione dall’umanità civile. Se qualcuno è in preda a tali sospetti è annientato. La sua vita di cittadino è distrutta, la sua reputazione scientifica rovinata.
E aggiunge:
Bisognerà dibattere dello stato dell’opinione pubblica in un paese in cui basta brandire la temibile accusa di negazionismo di Auschwitz [parola per parola: di colpirla con la mazza della menzogna di Auschwitz] per distruggere moralmente, nello spazio di un secondo, uno studioso famoso[1].
CONTRO LA LEGGE
La presente opera non può essere diffusa. La sua edizione è privata e fuori commercio. Il suo contenuto infrange la legge.
In Francia, è vietato contestare la Shoah.
Con l’applicazione di una legge del 13 luglio 1990 «sulla libertà di stampa», la Shoah, nelle sue tre ipostasi – il preteso genocidio degli ebrei, le pretese camere a gas naziste e i pretesi sei milioni di vittime ebree della seconda guerra mondiale – è diventata incontestabile pena la prigione da un mese ad un anno, un’ammenda da Frf 2.000 a 300.000 [€300 a €45.000 circa], il versamento del risarcimento danni e relativi interessi il cui ammontare può essere considerevole e pena altre sanzioni ancora. Più precisamente, questa legge vieta di contestare l’esistenza di uno o più «crimini contro l’umanità» come definiti nel 1945 e puniti nel 1946 dai giudici del Tribunale militare internazionale di Norimberga, tribunale istituito esclusivamente da vincitori per giudicare esclusivamente un vinto.
Certo, rimangono autorizzati dibattiti e controversie sulla Shoah – che è chiamata anche « Olocausto » – ma nel quadro tracciato dal dogma ufficiale. Controversie o dibattiti che porterebbero a rimettere in discussione tutta o parte della Shoah o semplicemente a revocarla in dubbio sono vietati. Ripetiamo: al riguardo, persino il dubbio è proscritto, e punito.
L’idea di una tale legge, d’ispirazione israeliana[2], era stata formulata, in Francia, per la prima volta nel 1986 da un certo numero di storici d’origine ebraica tra i quali Pierre Vidal-Naquet, Georges Wellers e François Bédarida, riuniti attorno al rabbino capo René-Samuel Sirat[3]. La legge fu votata nel 1990 grazie alle iniziative di Laurent Fabius, presidente dell’Assemblea nazionale ed egli stesso ebreo militante. Nello stesso periodo, una violazione di tombe nel cimitero ebraico di Carpentras diede luogo ad uno sfruttamento mediatico che paralizzò, nei deputati e nei senatori dell’opposizione, ogni velleità di resistenza effettiva al voto di questa legge. Nella città di Parigi, bandiere israeliane al vento, circa 200.000 manifestanti protestarono contro «il risorgere della bestia immonda». Il campanone di Notre-Dame fece sentire la sua voce come per un evento particolarmente tragico o significativo della storia di Francia. Una volta pubblicata la legge sul Journal officiel de la République française (la gazzetta ufficiale della repubblica francese – N.d.T.) (con nomina, lo stesso giorno, di P. Vidal-Naquet all’ordine della Legione d’onore), lo scandalo di Carpentras non fu più evocato se non di tanto in tanto, come promemoria. Non restò allora che la legge «Fabius-Gayssot».
A seguito delle pressioni di organizzazioni ebraiche nazionali ed internazionali, altri paesi adottarono a loro volta, su modello israeliano e francese, delle leggi che vietavano ogni contestazione della Shoah. Fu il caso della Germania, dell’Austria, del Belgio, della Svizzera, della Spagna e della Lituania. Altri paesi, ancora, del mondo occidentale hanno promesso alle organizzazioni ebraiche di fare altrettanto, in particolare la Gran Bretagna e il Canada. Ma, in realtà, una tale legge, di carattere specifico, non è indispensabile per la caccia al revisionismo storico. In Francia, come in altri paesi, c’è stato, e a volte resta, l’uso di perseguire i contestatori della Shoah con l’applicazione di altre leggi, per esempio quelle che reprimono, secondo il caso, il razzismo o l’antisemitismo, la diffamazione di persone vive, l’oltraggio alla memoria dei morti, l’apologia di crimine, la propagazione di notizie false e – fonte d’indennità pecuniarie per i querelanti – il danno ad altrui.
In Francia, poliziotti e giudici assicurano con rigore la protezione così accordata ad una versione ufficiale della storia della seconda guerra mondiale. Secondo questa versione rabbinica, l’evento maggiore del conflitto sarebbe stato la Shoah, altrimenti detto uno sterminio fisico o un tentativo di sterminio fisico degli ebrei che i Tedeschi avrebbero perpetrato dal 1941-1942 al 1944-1945 (non disponendo di nessun documento – e non senza ragione, poiché si tratta di fantasia – gli storici ufficiali non propongono altro che delle date tanto divergenti quanto approssimative).
CARATTERISTICA PARTICOLARE DELLA
PRESENTE OPERA: UNA CRONACA REVISIONISTA
Dal 1974 ad oggi ho dovuto condurre così tante battaglie giudiziarie da non aver trovato il tempo di redigere la relazione dimostrativa che ci si poteva attendere da un universitario che, per lunghi anni, abbia dedicato le proprie ricerche ad un solo ed unico punto della storia della seconda guerra mondiale: l’«Olocausto» o la Shoah.
Anno dopo anno, una valanga di processi, dalle più gravi conseguenze, è venuta a contrastare tutti i miei progetti di pubblicazione di una tale opera. Oltre ai miei processi personali, ho dovuto dedicare una buona parte del mio tempo alla difesa, dinanzi ai rispettivi tribunali, di revisionisti francesi e stranieri. Ancora oggi, nel momento in cui redigo quest’introduzione, mi attendono personalmente due processi (uno in Olanda e l’altro in Francia) mentre devo intervenire in maniera diretta o indiretta nei processi di revisionisti che vivono rispettivamente in Svizzera, Canada ed Australia. Per mancanza di tempo ho dovuto rifiutare il mio aiuto ad altri revisionisti, in particolare a due revisionisti giapponesi.
In tutto il mondo, la tattica dei nostri avversari è la stessa: appellarsi ai tribunali per paralizzare i lavori di ricerca dei revisionisti, qualora non si riesca ad ottenere la condanna di questi ultimi sia al carcere, sia al versamento d’ammende o di risarcimenti danni e relativi interessi. Per il condannato, il carcere comporterà l’interruzione d’ogni attività revisionista, mentre il versamento di ammende o di risarcimenti danni e relativi interessi significherà per lui la ricerca febbrile del denaro, una ricerca stimolata dalle minacce dell’ufficiale giudiziario, le «ordinanze di sequestro», gli «avvisi a terzi detentori» e il blocco del conto bancario. Solo da questo punto di vista, la mia vita, in quest’ultimo quarto di secolo, sarà stata difficile; tale rimane e, con ogni probabilità, tale resterà.
A ciò aggiungiamo, per aggravare la situazione, che la mia concezione della ricerca non è mai stata quella dell’universitario o dello storico «delle carte». Ritengo indispensabile recarmi sul posto: sia il sito dell’indagine materiale, sia il terreno su cui si schiera l’avversario. Io non posso parlare di Dachau, di Majdanek, di Auschwitz o di Treblinka senza recarmi sul posto per interrogarvi i luoghi e le persone. Io non posso sentir parlare di un’azione antirevisionista (manifestazione, conferenza, simposio, processo) senza recarmici di persona o senza delegarvi un osservatore da me preparato alla missione; il che non è senza rischio ma permette di ottenere delle informazioni da fonte appropriata. Io suscito innumerevoli lettere o interventi. Mi porto in tutte le feritoie. Per fare solo un esempio, io credo di poter dire che, se l’impressionante conferenza internazionale dell’«Olocausto» organizzata a Oxford nel 1988 dal miliardario Robert Maxwell (detto «Bob il bugiardo») è, per ammissione del suo stesso istigatore[4], pietosamente andata a monte, è grazie ad un’operazione che io ho personalmente condotto sul posto con l’ausilio di una revisionista francese che non mancava di coraggio, né d’audacia, né d’ingegnosità: la sua azione, da sola, sarà certamente valsa più di parecchi libri. Ma i facitori di libri a tutto spiano comprenderanno forse che cosa sto dicendo qui?
Ai giorni ed alle ore così passati nella preparazione dei processi o in quelle molteplici azioni tempestive, si aggiungeranno le ore e i giorni perduti negli ospedali a rimettersi sia dagli effetti di un’estenuante battaglia, sia dalle conseguenze d’aggressioni fisiche condotte da milizie ebraiche (in Francia, le milizie armate sono rigorosamente vietate salvo che per la comunità ebraica).
Infine, ho dovuto ispirare, dirigere o coordinare, in Francia o all’estero, molteplici azioni o lavori di carattere revisionista, sostenere le energie vacillanti, assicurare un cambio, rispondere alle chiamate, mettere in guardia contro le provocazioni, gli errori, le derive, e soprattutto lottare contro le compiacenze perché, in certi revisionisti, grande è la tentazione, in una simile battaglia, di cercare un compromesso con l’avversario e, a volte persino, di ritrattare. Purtroppo non mancano esempi in cui dei revisionisti, per farla finita, sono sprofondati nel pubblico pentimento. Io non scaglio loro la pietra. So per esperienza che lo scoraggiamento è in agguato per ognuno di noi perché la lotta è impari: i nostri mezzi sono irrisori e quelli dei nostri avversari, immensi.
Poiché necessità fa legge, la presente opera si riduce dunque ad una scelta di note, di articoli, di saggi, di prefazioni, d’interviste, di recensioni che ho redatto dal 1974 al 1998 e che sono qui presentati in ordine cronologico di composizione o di pubblicazione. Il lettore ne trarrà forse l’impressione di un insieme disparato, punteggiato di molte ripetizioni. Io sollecito la sua indulgenza. Per lo meno proprio questa diversità gli permetterà di seguire giorno dopo giorno l’avventura revisionista nelle sue vicissitudini. Quanto alle ripetizioni, accade che me ne consoli pensando che, tutto sommato, non mi sono ancora ripetuto abbastanza, poiché persistono oggi tanti fraintendimenti sull’esatta natura del revisionismo storico.
IL REVISIONISMO STORICO
Il revisionismo storico è una questione di metodo e non un’ideologia.
Esso preconizza, per ogni ricerca, il ritorno al punto di partenza, l’esame seguito dal riesame, la rilettura e la riscrittura, la valutazione seguita da una nuova valutazione, il nuovo orientamento, la revisione, il rifacimento; esso è, nello spirito, il contrario dell’ideologia. Esso non nega ma mira ad affermare con maggiore esattezza. I revisionisti non sono dei «negatori» o dei «negazionisti»; essi si sforzano di cercare e di trovare là dove, pare, non c’era più niente da cercare né da trovare.
Il revisionismo può esercitarsi in cento attività della vita d’ogni giorno e in cento campi della ricerca storica, scientifica o letteraria. Esso non rimette per forza in discussione delle idee acquisite, ma spesso induce a sfumarle. Esso cerca di districare il vero dal falso. La storia è, per essenza, revisionista; l’ideologia le è nemica. Siccome l’ideologia non è mai così forte come in tempo di guerra o di conflitto, e siccome essa produce allora falsità a iosa per le necessità della propria propaganda, lo storico sarà, in tale circostanza, indotto a raddoppiare la vigilanza: passando al vaglio dell’esame ciò che è stato possibile rifilargli come «verità», egli si accorgerà probabilmente che, là dove una guerra ha provocato decine di milioni di vittime, la prima di queste sarà stata la verità verificabile: una verità che si tratterà di cercare e di ristabilire.
La storia ufficiale della seconda guerra mondiale contiene un po’ di vero combinato con molte falsità.
LA STORIA UFFICIALE:
UN PO’ DI VERO COMBINATO CON MOLTE FALSITÀ.
I SUOI ARRETRAMENTI SUCCESSIVI DI FRONTE ALLE AVANZATE
DEL REVISIONISMO STORICO
È esatto dire che la Germania nazionalsocialista ha creato dei campi di concentramento; essa lo ha fatto dopo – e contemporaneamente a – molti altri paesi, tutti convinti che questi campi sarebbero stati più umani della prigione; Hitler vedeva in questi campi ciò che Napoleone III aveva creduto di vedere nella creazione delle colonie penitenziarie: un progresso per l’uomo. Ma è falso che la Germania abbia mai creato dei «campi di sterminio» (espressione coniata dagli Alleati).
È esatto dire che i Tedeschi hanno fabbricato dei furgoni funzionanti a gas (Gaswagen). Ma è falso che essi abbiano mai fabbricato dei furgoni a gas omicidi (se uno solo di questi furgoni fosse esistito, esso si troverebbe al Museo dell’automobile o nei musei dell’«Olocausto», se non altro sotto forma di bozzetto di valore scientifico).
È esatto dire che i Tedeschi usavano lo Zyklon (prodotto a base d’acido cianidrico utilizzato sin dal 1922) per proteggere con la disinfestazione dagli insetti la salute dei civili, delle truppe, dei prigionieri o degli internati. Ma essi non hanno mai impiegato lo Zyklon per uccidere chicchessia e soprattutto non schiere d’esseri umani; date le drastiche precauzioni d’uso del gas cianidrico, le pretese gassazioni omicide di Auschwitz o di altri campi sarebbero state, d’altronde, radicalmente impossibili; io mi dilungo molto su questo punto nel corpo della presente opera.
È esatto dire che i Tedeschi concepivano una «soluzione finale della questione ebraica» (Endlösung der Judenfrage). Ma questa soluzione era territoriale (territoriale Endlösung der Judenfrage) e non omicida; si trattava di spingere o, se necessario, di forzare gli ebrei a lasciare la Germania e la sua sfera d’influenza in Europa per stabilire, in accordo con i sionisti, un focolare nazionale ebraico, nel Madagascar o altrove. Molti sionisti hanno collaborato con la Germania nazionalsocialista per questa soluzione.
È esatto dire che dei Tedeschi si sono riuniti, il 20 gennaio 1942, in una villa in una zona periferica di Berlino (Berlin-Wannsee) per trattare della questione ebraica. Ma essi vi hanno progettato l’emigrazione forzata o la deportazione degli ebrei nonché la futura creazione di una specifica entità ebraica e non un programma di sterminio fisico.
È esatto dire che dei campi di concentramento possedevano dei forni crematori per la cremazione dei cadaveri. Ma era per meglio combattere le epidemie e non per bruciarvi, come si è osato talvolta affermare, degli esseri viventi oltre ai cadaveri[5].
È esatto dire che gli ebrei hanno conosciuto le sofferenze della guerra, dell’internamento, della deportazione, dei campi di detenzione, dei campi di concentramento, dei campi di lavori forzati, dei ghetti, delle epidemie, delle esecuzioni sommarie per ogni sorta di ragione; essi hanno anche subito rappresaglie o addirittura massacri, perché non c’è guerra senza massacri. Ma è altrettanto vero che tutte queste sofferenze sono toccate anche a molte altre nazioni o comunità durante la guerra e, in particolare, ai Tedeschi e ai loro alleati (lasciando da parte le sofferenze dei ghetti, perché il ghetto è in primo luogo e prima di tutto una creazione specifica degli ebrei stessi[6]); è soprattutto verosimile, per chi non è affetto da memoria emiplegica e per chi si sforza di conoscere le due facce della storia della seconda guerra mondiale (la faccia sempre mostrata e la faccia quasi sempre nascosta), che le sofferenze dei vinti durante la guerra e dopo la guerra sono state, per numero e qualità, peggiori di quelle degli ebrei e dei vincitori, soprattutto per quanto riguarda le deportazioni.
È falso che, come si è osato per molto tempo pretendere, sia esistito un ordine qualunque di Hitler o di uno dei suoi stretti collaboratori di sterminare gli ebrei. Durante la guerra, dei soldati e degli ufficiali tedeschi sono stati condannati dalle proprie corti marziali, e a volte fucilati, per aver ucciso degli ebrei.
È un bene che gli sterminazionisti (cioè coloro che credono allo sterminio degli ebrei) abbiano finito, stufi di lottare, col riconoscere che non si trova traccia di alcun piano, di alcuna istruzione, di alcun documento relativo ad una politica di sterminio fisico degli ebrei e che, allo stesso modo, essi abbiano infine ammesso che non si trova traccia di alcun bilancio stanziato per una simile impresa né di un qualche organismo incaricato di portare a buon fine una tale politica.
È un bene che gli sterminazionisti abbiano infine concesso ai revisionisti che i giudici del processo di Norimberga (1945-1946) hanno accettato come veri dei fatti di pura invenzione, come la storia del sapone fabbricato con il grasso degli ebrei, la storia dei paralumi fatti di pelle umana, quella delle «teste rimpicciolite», la storia delle gassazioni omicide di Dachau; e soprattutto è un bene che gli sterminazionisti abbiano infine riconosciuto che l’elemento più spettacolare, più terrificante, più significativo di questo processo, cioè l’udienza del 15 aprile 1946, nel corso della quale si è visto e sentito un ex-comandante del campo di Auschwitz (Rudolf Höss) confessare pubblicamente che, nel suo campo, erano stati gassati milioni di ebrei, non era che il risultato di torture inflitte a quest’ultimo. Questa confessione, presentata per tanti anni e in tante opere storiche come la «prova» n. 1 del genocidio degli ebrei, è ora relegata nell’oblio, per lo meno dagli storici.
È una fortuna che degli storici sterminazionisti abbiano infine riconosciuto che la famosa testimonianza dell’SS Kurt Gerstein, elemento essenziale della loro tesi, è priva di valore; è odioso che l’Università francese abbia ritirato al revisionista Henri Roques il suo titolo di dottore per averlo dimostrato nel 1985.
È penoso che Raul Hilberg, il papa dello sterminazionismo, abbia osato scrivere, nel 1961, nella prima edizione di The Destruction of the European Jews, che erano esistiti due ordini di Hitler di sterminare gli ebrei, per poi dichiarare, a partire dal 1983, che questo sterminio si era compiuto da solo, senza alcun ordine né piano ma attraverso un «incredibile incontro degli spiriti, una trasmissione di pensiero consensuale» in seno alla vasta burocrazia tedesca. R. Hilberg ha così sostituito l’asserzione gratuita con la spiegazione magica (la telepatia).
È un bene che gli sterminazionisti abbiano infine, in pratica, quasi abbandonato l’accusa, corredata da «testimonianze», secondo la quale esistevano delle camere a gas omicide a Ravensbrück, ad Oranienburg-Sachsenhausen, a Mauthausen, a Hartheim, nel campo di Struthof-Natzweiler, in quello di Stutthof-Danzica, a Bergen-Belsen,…
È un bene che la camera a gas nazista più visitata al mondo – quella di Auschwitz-I – sia stata infine riconosciuta, nel 1995, per ciò che era, cioè un montaggio. È una fortuna che sia stato infine ammesso che «LÀ TUTTO È FALSO» e, personalmente, mi rallegro del fatto che uno storico appartenente all’establishment abbia potuto scrivere: «Alla fine degli anni ’70, Robert Faurisson sfruttò tanto meglio queste falsificazioni in quanto i responsabili del museo erano allora restii a riconoscerle»[7]. Io me ne rallegro tanto più in quanto in fondo la giustizia francese mi aveva, in modo iniquo, condannato per averlo detto.
È un bene che, nello stesso articolo, lo stesso storico abbia rivelato che un luminare del mondo ebraico come Théo Klein non vede in questa «camera a gas» altro che un «artificio».
È altresì un bene che, nello stesso articolo, lo stesso storico abbia rivelato dapprima che le autorità del Museo di Auschwitz sono consapevoli di aver ingannato milioni di visitatori (500.000 all’anno all’inizio degli anni ’90), poi che esse continueranno nondimeno in futuro ad ingannare i visitatori perché, secondo la vicedirettrice del museo: «[Dire la verità su questa “camera a gas”] è troppo complicato. Vedremo più avanti»![8]
È una fortuna che nel 1996 due storici d’origine ebraica, il Canadese Robert Jan van Pelt e l’Americana Debórah Dwork, abbiano, finalmente, denunciato alcuni degli enormi imbrogli del campo-museo di Auschwitz e il cinismo con cui s’ingannano i visitatori[9].
È, invece, inammissibile che l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) mantenga dal 1979 il patrocinio su un sito come quello di Auschwitz il cui centro racchiude, in questa falsa «camera a gas» (senza contare altre enormi falsificazioni), un’impostura ora appurata; l’UNESCO (organizzazione che ha sede a Parigi e che è diretta da Federico Mayor) non ha il diritto di utilizzare i contributi dei paesi aderenti per farsi garante di un grande imbroglio talmente contrario all’«istruzione», alla «scienza» e alla «cultura».
È una fortuna che Jean-Claude Pressac, dopo essere stato portato alle stelle, sia caduto nel discredito. Portato alla ribalta dalla coppia Klarsfeld, questo farmacista ha ritenuto intelligente cercare una posizione intermedia tra coloro che credono alle camere a gas e coloro che non ci credono. Per lui, in qualche modo, la donna da esaminare non era né incinta né non incinta ma a metà incinta e addirittura, con il passare del tempo, sempre meno gravida. Autore di scritti che si presumeva vertessero sulle camere a gas naziste ma nei quali non si riusciva a trovare né una fotografia d’insieme, né un disegno d’insieme di uno solo di questi mattatoi chimici, il penoso pasticcione doveva dare la dimostrazione, il 9 maggio 1995, presso la XVIIa sezione del tribunale correzionale di Parigi, della sua totale incapacità di rispondere alle domande della presidente del tribunale su quello che avrebbe ben potuto essere uno di questi mattatoi. Tre anni dopo, egli è ridotto a scrivere: «Così, a dire di ex-membri del Sonderkommando, si desume con grande certezza che sia stato girato un film sulle gassazioni omicide dalle SS a Birkenau. Perché esso non sarebbe stato ritrovato per caso nel solaio o nella cantina di un ex-appartenente alle SS?»[10].
È una fortuna che i resti della «camera a gas», appartenente al Krematorium II di Birkenau (Auschwitz-II), possano soprattutto servire a dimostrare «in vivo» e «de visu» che non c’è mai stato «Olocausto», né in questo campo né altrove. Infatti, stando agli interrogatori di un imputato tedesco e secondo delle fotografie aeree «ritoccate» dagli Alleati, il tetto di questa camera a gas avrebbe posseduto quattro aperture speciali (di 25 cm x 25 cm, si precisava) per versare lo Zyklon. Ora, tutti possono costatare sul posto che nessuna di queste aperture esiste né è mai esistita. Essendo Auschwitz la capitale dell’«Olocausto» ed essendo questo crematorio in rovina al centro dello sterminio degli ebrei ad Auschwitz, io ho potuto dire nel 1994 – e la formula sembra aver fatto strada nelle menti: «No holes, no “Holocaust”» (Niente orifizi, niente «Olocausto»).
È altresì una fortuna che sia stata così finalmente invalidata una pletora di «testimonianze» secondo le quali quelle gassazioni erano esistite ed è, allo stesso tempo, estremamente deplorevole che tanti Tedeschi, giudicati dai loro vincitori, siano stati condannati ed a volte addirittura giustiziati per dei crimini che essi non avevano potuto commettere.
È un bene che alla luce di processi che assomigliano a delle farse giudiziarie gli sterminazionisti stessi emettano dei dubbi sulla validità di molte testimonianze; queste testimonianze apparirebbero ancora più chiaramente errate se ci si prendesse finalmente la briga di ordinare delle perizie giudiziarie della presunta arma del presunto crimine, poiché, in occasione di mille processi riguardanti Auschwitz o altri campi, nessun tribunale ha ordinato una tale perizia (con la sola eccezione, assai poco nota, del campo di Struthof-Natzweiler, i cui risultati sono stati tenuti nascosti fino a quando io li ho rivelati). Eppure si sapeva bene che testimonianze o confessioni devono essere circostanziate e verificate e che, mancando queste due condizioni, esse sono prive di valore probatorio.
È una fortuna che la storia ufficiale abbia riveduto per difetto – spesso in proporzioni considerevoli – il supposto numero delle vittime. Ci sono voluti più di quarant’anni di pressioni revisioniste perché le autorità ebraiche e quelle del Museo di Auschwitz ritirassero le diciannove targhe che, in diciannove lingue diverse, annunciavano che il numero delle vittime del campo ammontava a quattro milioni. Ci sono poi voluti cinque anni di dispute interne perché ci si accordasse sulla nuova cifra di un milione mezzo, cifra che, in seguito, a sua volta, è stata ben presto contestata da autori sterminazionisti: J.-C. Pressac, il protetto di S. Klarsfeld, non propone più, per parte sua, se non la cifra di 600.000-800.000 vittime ebree e non ebree per tutto il periodo in cui è esistito il complesso di Auschwitz. È un peccato che questa ricerca della vera cifra non prosegua per raggiungere la cifra probabile di 150.000 persone, vittime, principalmente, di epidemie in quasi quaranta campi del complesso di Auschwitz. È deplorevole che, nelle scuole di Francia, si continui a proiettare il film Nuit et Brouillard dove il numero dei morti di Auschwitz è fissato a nove milioni; inoltre, in questo film si perpetua il mito del «sapone fabbricato con i corpi», quello dei paralumi di pelle umana e quello delle tracce di unghie delle vittime nel cemento delle camere a gas; s’intende dire che «niente distingueva la camera a gas da un normale blocco di edifici»!
È un bene che nel 1988 Arno Mayer, professore d’origine ebraica, docente all’università di Princeton, abbia all’improvviso scritto: «Le fonti per lo studio delle camere a gas sono allo stesso tempo rare e dubbie»; ma perché aver affermato per così tanto tempo che le fonti erano innumerevoli e degne di fede, e perché aver vilipeso i revisionisti che scrivevano già nel 1950 ciò che Arno Mayer scopriva nel 1988?
È soprattutto un bene che nel 1996 uno storico, Jacques Baynac, che aveva fatto una sua specialità, anche sul giornale Le Monde, di trattare i revisionisti da falsari, abbia infine riconosciuto che non c’è, in definitiva, nessuna prova dell’esistenza delle camere a gas. È, precisa, «difficile da dire così come da sentire»[11]. Forse, in certe circostanze, la verità è, per alcuni, «difficile da dire così come da sentire» ma, per i revisionisti, la verità è piacevole a dirsi così come a sentirsi.
È infine una fortuna che gli sterminazionisti si siano permessi di intaccare il terzo ed ultimo elemento della trinità della Shoah: la cifra di sei milioni di morti ebrei. Sembra che questa cifra sia stata portata alla ribalta per la prima volta[12], circa un anno prima della fine della guerra in Europa, dal rabbino Michael Dov Weissmandel (1903-1956); insediato in Slovacchia, questo rabbino è stato l’artefice principale della menzogna di Auschwitz a partire dalle pretese testimonianze di Slovacchi come Rudolf Vrba e Alfred Wetzler; egli organizzava delle intense «campagne d’informazione» in direzione degli Alleati, della Svizzera e del Vaticano. In una lettera del 31 maggio 1944 (la guerra con la Germania è finita l’8 maggio 1945), egli non esitava a scrivere: «Fino ad oggi, sei volte un milione di ebrei d’Europa e di Russia sono stati distrutti»[13].
Anche molto tempo prima della fine della guerra, si trova questa cifra di sei milioni presso l’ebreo sovietico Ilya Ehrenburg (1891-1967) che fu forse il più astioso propagandista della seconda guerra mondiale[14]. Nel 1979, questa cifra è stata improvvisamente qualificata come «simbolica» (cioè come falsa) dallo sterminazionista Martin Broszat in occasione del processo ad un revisionista tedesco. Nel 1961, Raul Hilberg, il più prestigioso degli storici convenzionali, stimava il numero dei morti ebrei a 5,1 milioni. Nel 1953, un altro di questi storici, Gerald Reitlinger, aveva proposto una cifra compresa tra 4,2 e 4,6 milioni. Ma, in effetti, nessuno storico di questa scuola ha presentato delle cifre fondate su un’indagine; non si tratta che di calcoli approssimativi soggettivi. Il revisionista Paul Rassinier, per parte sua, ha avanzato la cifra di un milione circa di morti ebrei, ma partendo, precisava, da cifre fornite dalla parte avversa; dunque anche qui, si trattava di un calcolo approssimativo. La verità è che molti ebrei europei sono periti e molti sono sopravvissuti. Con i moderni mezzi di calcolo, dovrebbe essere possibile determinare che cosa significhi «molti» in ognuno dei due casi. Ma le tre fonti alle quali si potrebbero attingere le informazioni necessarie sono, in pratica, interdette ai ricercatori indipendenti o il loro accesso è limitato:
– si tratta in primo luogo dell’enorme documentazione raccolta dal Servizio internazionale di ricerche (SIR) di Arolsen-Waldeck (Germania), che dipende dal Comitato internazionale della Croce Rossa (Svizzera) ed il cui accesso è gelosamente controllato da dieci Stati tra i quali quello d’Israele;
– si tratta poi dei documenti posseduti dalla Polonia e dalla Russia e di cui solo una parte è stata resa accessibile: registri mortuari di certi campi, registri delle cremazioni, ecc.;
– si tratta infine dei nomi dei milioni di sopravvissuti ebrei che hanno percepito o percepiscono delle indennità o riparazioni finanziarie, sia in Israele, sia in parecchie decine di paesi rappresentati in seno al Congresso mondiale ebraico. La semplice enumerazione di questi nomi mostrerebbe a che punto una comunità spesso detta «sterminata» non è stata affatto sterminata.
Ancora a cinquantadue anni dalla guerra, lo Stato d’Israele valuta ufficialmente a circa 900.000 il numero dei «sopravvissuti» dell’«Olocausto» nel mondo (esattamente: tra 834.000 e 960.000)[15]. Secondo una stima dello statistico svedese Carl O. Nordling, al quale io ho sottoposto questa valutazione del governo israeliano, è possibile, partendo dall’esistenza di 900.000 «sopravvissuti» nel 1997, concludere che esistessero, nel 1945, un po’ più di tre milioni di «sopravvissuti» al termine della guerra. Ancora oggi, pullulano le organizzazioni di «sopravvissuti» sotto le denominazioni più diverse; esse riuniscono sia ex-«membri della resistenza» ebrei che ex-bambini di Auschwitz (cioè bambini ebrei nati in questo campo o internati in tenera età con i genitori), ebrei destinati ai lavori forzati o, più semplicemente, fuggiaschi o clandestini ebrei. Milioni di «miracolati» non sono più un «miracolo» ma il prodotto di un fenomeno naturale. La stampa americana riferisce abbastanza spesso di ricongiungimenti tra sopravvissuti di una stessa famiglia di cui ogni membro era, ci assicurano, convinto fino a quel momento che «tutta la sua famiglia» fosse scomparsa.
Riassumendo, nonostante il dogma e nonostante le leggi, la ricerca della verità storica sulla seconda guerra mondiale in generale e sulla Shoah in particolare ha fatto progressi in questi ultimi anni; il grande pubblico è tenuto nell’ignoranza di questi progressi; sarebbe sbalordito nell’apprendere che molte delle sue credenze più solide sono state, dall’inizio degli anni ’80, relegate dagli storici più ortodossi nello scaffale delle leggende popolari. Si potrebbe dire che esistono, da questo punto di vista, due concezioni dell’«Olocausto»: da una parte, quella del grande pubblico e, dall’altra, quella degli storici conformisti; l’una sembra incrollabile mentre l’altra minaccia di crollare, talmente che si procede a delle frettolose riparazioni.
Le concessioni fatte ai revisionisti dagli storici ortodossi, anno dopo anno, soprattutto a partire dal 1979, sono state così importanti per numero e qualità che questi storici si trovano oggi in un vicolo cieco. Essi non hanno più niente da dire di sostanziale sull’argomento stesso dell’«Olocausto». Hanno passato la staffetta ai cineasti, ai romanzieri, alla gente di teatro. Anche coloro che si occupano di museografia sono in panne. All’Holocaust Memorial Museum di Washington è stata presa la «decisione» di non offrire ai visitatori «nessuna rappresentazione fisica delle camere a gas» (dichiarazione che mi è stata fatta nell’agosto 1994 da Michel Berenbaum, responsabile scientifico del museo, in presenza di quattro testimoni, ed autore di un libro-guida di più di duecento pagine dove, infatti, non si trova nessuna rappresentazione fisica delle camere a gas, neanche di un misero e fallace plastico pur tuttavia presentato ai visitatori)[16]. I visitatori del museo non hanno il diritto di scattare fotografie. Claude Lanzmann, autore di Shoah, film che spicca per l’assenza di contenuto storico o scientifico, non ha oggi più altra risorsa che di pontificare deplorando che «i revisionisti occupino tutto il campo»[17]. Quanto a Elie Wiesel, egli fa appello alla discrezione di tutti; ci scongiura di non cercare più di vedere da vicino o d’immaginare cosa succedeva, secondo lui, nelle camere a gas; «Le camere a gas, è meglio che restino chiuse agli sguardi indiscreti. E all’immaginazione»[18]. Gli storici dell’«Olocausto» si sono tramutati in teorici, in filosofi, in pensatori. Le loro baruffe tra «intenzionalisti» e «funzionalisti» o persino tra sostenitori ed avversari di una tesi come quella di Daniel Goldhagen sulla propensione quasi naturale dei Tedeschi a versare nell’antisemitismo e nel crimine razzista non riuscirebbero a dissimularci l’indigenza dei loro lavori propriamente storici.
SUCCESSI ED INSUCCESSI DEL REVISIONISMO
Nel 1998 il bilancio consuntivo dell’impresa revisionista si colloca come segue: un successo strepitoso sul piano della storia e della scienza (su questo piano i nostri avversari hanno firmato la capitolazione nel 1996) ma un insuccesso sul piano della comunicazione (i nostri avversari hanno bloccato ogni accesso dei revisionisti ai media salvo, per il momento, alla rete Internet).
Negli anni ’80 e nei primi anni ’90 degli autori antirevisionisti avevano tentato d’incrociare le spade con i revisionisti sul terreno della scienza storica. Di volta in volta, Pierre Vidal-Naquet, Nadine Fresco, Georges Wellers, Adalbert Rückerl, Hermann Langbein, Eugen Kogon, Arno Mayer o Serge Klarsfeld (quest’ultimo con l’aiuto del farmacista Jean-Claude Pressac) avevano cercato di far credere ai media che era stata trovata una risposta alle argomentazioni materiali o documentarie dei revisionisti. Persino Michael Berenbaum, persino l’Holocaust Memorial Museum avevano, nel 1993 ed all’inizio del 1994, voluto raccogliere la sfida che io avevo lanciato di mostrarci non foss’altro che una sola camera a gas nazista e non foss’altro che una sola prova, a loro scelta, che era esistito un genocidio degli ebrei. Ma i loro fallimenti sono stati così cocenti che hanno dovuto progressivamente abbandonare la lotta su questo terreno. Proprio di recente, nel 1998, M. Berenbaum ha effettivamente pubblicato una ponderosa opera intitolata: The Holocaust and History[19]; ma, precisamente, lungi dallo studiarvi ciò che egli chiama l’«Olocausto» a livello della storia (cosa che aveva espressamente tentato A. Mayer nel 1988), ci mostra piuttosto, senza volerlo, che l’«Olocausto» è una cosa e la «Storia» tutt’altra cosa. D’altronde, l’opera è quasi immateriale. Non contiene né una fotografia, né un disegno, né il minimo tentativo di rappresentare fisicamente una qualunque realtà. Solo la copertina dell’opera dà a vedere… un mucchio di scarpe. Si suppone che queste scarpe siano eloquenti come all’Holocaust Memorial Museum di Washington dove esse ci sembrano dire: «We are the shoes, we are the last witnesses» (Noi siamo le scarpe, siamo gli ultimi testimoni). L’opera non è altro che un insieme di cinquantacinque contributi scritti e pubblicati sotto l’alta sorveglianza del rabbino Berenbaum; anche Raul Hilberg, anche Yehuda Bauer, anche Franciszek Piper ivi rinunciano ad ogni vero e proprio sforzo di ricerca scientifica ed ivi è pronunciato l’anatema contro un Arno Mayer che, in un recente passato, aveva tentato di ricollocare l’«Olocausto» nella storia[20]. L’irrazionale ha avuto la meglio sui tentativi di razionalizzazione. E. Wiesel, C. Lanzmann, Steven Spielberg (con un film, Schindler’s List, ispirato da un romanzo), hanno infine trionfato su coloro che, nel proprio campo, cercavano di provare l’«Olocausto».
Il futuro mostrerà in retrospettiva che è stato nel settembre 1996 che è suonata la campana a morto per le speranze di coloro che avevano voluto combattere il revisionismo sul terreno della scienza e della storia. I due lunghi articoli pubblicati in quel periodo dallo storico antirevisionista J. Baynac su un giornale elvetico hanno definitivamente chiuso il capitolo dei tentativi di risposta razionale alle argomentazioni dei revisionisti[21].
A metà e alla fine degli anni ’70, io avevo apportato il mio contributo allo sviluppo del revisionismo; avevo allora scoperto e formulato ciò che si è, da allora, convenuto di chiamare l’argomentazione fisico-chimica, cioè le ragioni fisiche e chimiche per le quali le pretese camere a gas naziste erano semplicemente inconcepibili. A quel tempo, mi vantavo di aver portato alla luce un’argomentazione decisiva che non era stata fino a quel momento esposta né da un chimico tedesco (la Germania non manca di chimici), né da un ingegnere americano (gli Stati Uniti possiedono degli ingegneri che, viste le drastiche complicazioni richieste per la costruzione di una camera a gas nei penitenziari del loro paese, avrebbero dovuto rendersi conto che era impossibile fabbricare le pretese camere a gas naziste per ragioni fisico-chimiche). Se in quel periodo, nel bel mezzo del chiasso provocato dalla mia scoperta, un indovino mi avesse predetto che, vent’anni dopo, verso il 1994-1996, i miei avversari, dopo parecchi tentativi di mostrare che io ero in errore, si sarebbero rassegnati, come ha fatto J. Baynac, a riconoscere che in fin dei conti non esiste la minima prova della realtà di una sola camera a gas nazista, io me ne sarei certamente rallegrato. E ne avrei forse concluso che il mito dell’«Olocausto», colpito al cuore, non sarebbe sopravvissuto, che i media avrebbero abbandonato il servizio della Grande Menzogna e che, in modo del tutto normale, la repressione antirevisionista si sarebbe estinta da sola.
Avrei commesso qui un errore di diagnosi e di prognosi allo stesso tempo. Perché le credenze superstiziose vivono di una vita diversa da quella della scienza. Esse vanno per la loro strada. Il mondo della religione, dell’ideologia, dell’illusione, dei media e del cinema di fantasia può svilupparsi al di fuori delle realtà scientifiche. Nemmeno Voltaire è mai riuscito a «schiacciare l’infame». Così si potrebbe dire che, come Voltaire nel denunciare le assurdità dei racconti ebraici, i revisionisti sono condannati, nonostante il carattere scientifico dei loro lavori, a non prevalere mai sulle elucubrazioni della Sinagoga; tuttavia essa, la Sinagoga, non riuscirà mai a soffocare la voce dei revisionisti. La propaganda dell’«Olocausto» e lo «Shoah-Business» continueranno a prosperare. Resta oggi ai revisionisti di mostrare come queste credenze, questo mito, siano riusciti a nascere, crescere, poi a prosperare prima, forse, di scomparire per lasciare il posto, un giorno, non alla ragione ma ad altre credenze e ad altri miti.
Come vengono ingannati gli uomini e perché essi stessi s’ingannano così volentieri?
LA PROPAGANDA DELL’«OLOCAUSTO»: MOSTRARE DEI
MORTI E PARLARE DI MORTI AMMAZZATI,
MOSTRARE DEI FORNI CREMATORI
E PARLARE DI CAMERE A GAS
È con la manipolazione delle immagini che è più facile trarre in inganno le masse. Sin dall’aprile 1945 dei giornalisti britannici ed americani si sono affrettati, all’apertura dei campi di concentramento tedeschi, a fotografare o a filmare degli orrori veri di cui si sono poi fatti, se così si può dire, degli orrori più veri del naturale. Nel linguaggio popolare caro al mondo della stampa, è stato fatto «un bidone»; ci è stato fornito un po’ di «Timisoara» ante litteram[22]. Da una parte, ci sono stati mostrati dei morti veri nonché degli autentici crematori; dall’altra, grazie a dei commenti fallaci e ad una messa in scena cinematografica, si è proceduto ad un abile raggiro il cui risultato può essere sintetizzato in una formula atta a servire da sesamo per la scoperta di tutte queste imposture: «Siamo stati indotti a prendere dei morti per dei morti ammazzati e dei forni crematori per delle camere a gas omicide». Verrebbe voglia di aggiungere: «…e lucciole per lanterne».
Così è nata la confusione, ancora tanto diffusa ai giorni nostri, tra, da una parte, i forni crematori, che sono realmente esistiti (ma non a Bergen-Belsen) per servire alla cremazione dei morti, e, dall’altra, le camere a gas naziste che, esse, sarebbero servite ad uccidere frotte di uomini e donne, ma che non sono, in realtà, mai esistite né sono potute esistere.
Il mito, sotto la sua forma mediatica, delle camere a gas naziste associate a dei forni crematori trova il suo punto di partenza nelle immagini e nei commenti della stampa riguardo a un campo – Bergen-Belsen – che, persino secondo il parere degli storici ortodossi, non possedeva né camere a gas omicide e nemmeno dei semplici forni crematori.
«CAMERE A GAS» MAI VISTE, MAI MOSTRATE
Nel marzo 1992, a Stoccolma, durante una conferenza stampa, io lanciavo una sfida alla platea di giornalisti della carta stampata e della televisione. Questa sfida era racchiusa in poche parole: «Mostratemi o disegnatemi una camera a gas nazista!»
L’indomani i giornalisti riportavano la conferenza stampa ma ne passavano sotto silenzio l’oggetto essenziale: precisamente, questa sfida. Essi avevano cercato delle fotografie e non ne avevano trovate.
Miliardi di uomini, in questo mezzo secolo, s’immaginano (o si sono immaginati) di aver visto delle camere a gas naziste sui libri o in documentari. Molti si sono convinti di essersi, almeno una volta nella loro vita, imbattuti nella fotografia di una simile camera a gas. Alcuni hanno visitato Auschwitz o altri campi dove le guide hanno spiegato loro che tale locale era stato una camera a gas. Si è detto loro che avevano sotto gli occhi una camera a gas, secondo il caso, «allo stato originario» o «allo stato di ricostruzione» (implicando quest’ultima formula che detta ricostruzione è fedele e conforme all’originale). Talvolta, dei resti sono stati designati loro come «resti di una camera a gas»[23]. Ora, in ogni caso, essi sono stati ingannati o, meglio, si sono ingannati da soli. Questo fenomeno si spiega facilmente. Troppe persone s’immaginano che una camera a gas possa ridursi ad un vano qualunque con dentro del gas. Equivale a confondere una gassazione per un’esecuzione capitale con una gassazione suicida o accidentale. Una gassazione per un’esecuzione capitale, come negli Stati Uniti per mettere a morte un solo condannato, presenta necessariamente una temibile complessità perché, in questo caso, bisognerà badare ad uccidere senza provocare incidenti e senza mettere in pericolo la propria vita o quella delle persone che stanno intorno, soprattutto nella fase finale, cioè quando bisognerà penetrare nel locale per manipolarvi un cadavere contaminato ed estrarlo dalla camera a gas. Questo, la maggior parte dei visitatori di musei, nonché la maggior parte dei lettori, la maggior parte degli spettatori di film e persino la maggior parte degli storici lo ignorano manifestamente. I responsabili dei musei, da parte loro, traggono profitto da quest’ignoranza generale. A guisa di camera a gas nazista, basta loro presentare al bravo pubblico un locale dall’apparenza lugubre, una cella frigorifera d’obitorio, una stanza docce (situata di preferenza in un sotterraneo), un rifugio antiaereo (dotato di una porta con spioncino) e il gioco sarà fatto. Gli imbroglioni possono accontentarsi di meno: basta loro far vedere una semplice porta, un muro, un tetto di una pretesa «camera a gas». Gli imbroglioni più avveduti si accontenteranno di ancor meno: mostreranno un fagotto di capelli, un cumulo di scarpe, un mucchio d’occhiali e pretenderanno che si tratta delle sole tracce o vestigia dei «gassati» che siano state ritrovate; ovviamente, si guarderanno dal ricordare che, durante la guerra e il blocco economico, in un’Europa in preda alla carestia e alla penuria, si procedeva al «ricupero», poi al «riciclaggio» di qualsiasi materiale trasformabile, compresi i capelli, che, per parte loro, servivano, per esempio, per confezionare indumenti.
TESTIMONI DELL’«OLOCAUSTO»:
TESTIMONIANZE NON VERIFICATE
A proposito dei testimoni regna la stessa confusione. Ci presentano delle coorti di testimoni del genocidio degli ebrei. A parole o con gli scritti, questi testimoni pretendono di attestare che la Germania eseguiva un piano di sterminio generale degli ebrei in Europa. In realtà, questi testimoni possono soltanto attestare la realtà della deportazione, quella dei campi di detenzione, dei campi di concentramento o dei campi di lavori forzati, e persino, in qualche caso, del funzionamento dei forni crematori. Gli ebrei erano così poco votati allo sterminio o alle camere a gas omicide, che ciascuno di questi innumerevoli testimoni sopravvissuti o superstiti, lungi dal costituire, come ci si vuole far credere, una «prova vivente del genocidio», è, al contrario, una prova vivente del fatto che non c’è stato genocidio. Come si è visto sopra, alla fine della guerra il numero dei «sopravvissuti» ebrei all’«Olocausto» superava probabilmente la cifra di tre milioni.
Per il solo campo di Auschwitz, è considerevole l’elenco degli ex-internati ebrei che, sullo sterminio degli ebrei in questo campo, hanno portato una testimonianza pubblica a parole o con gli scritti, alla televisione, sui libri, dinanzi ai tribunali.
Tra i più noti, citiamo:
Odette Abadie, Louise Alcan, Esther Alicigüzel, Jehuda Bacon, Charles Baron, Bruno Baum, Charles-Sigismond Bendel, Maurice Benroubi, Henri Bily, Ada Bimko, Suzanne Birnbaum, Eva Brewster, Henry Bulawko, Robert Clary, Jehiel Dinour alias K. Tzetnik, Szlama Dragan, Fania Fénelon, Arnold Friedman, Philip Friedman, Michel Gelber, Israël Gutman, Dr. Hafner, Henry Heller, Benny Hochman, Régine Jacubert, Wanda Jakubowska, Stanislas Jankowski alias Alter Fajnzylberg, Simone Kadosche, Raya Kagan, Rudolf Kauer, Marc Klein, Ruth Klüger, Guy Kohen, Erich Kulka, Simon Laks, Hermann Langbein, Leo Laufer, Sonia Letwinska, Renée Louria, Henryk Mandelbaum, Françoise Maous, Mel Mermelstein, Ernest Morgan, Filip Müller, Flora Neumann, Anna Novac, Miklos Nyiszli, David Olère, Dounia Ourisson, Dov Paisikovic, Gisella Perl, Samuel Pisar, Macha Ravine-Speter, Jérôme Scorin, Georges Snyders, Henri Sonnenbluck, Jacques Stroumsa, David Szmulewski, Henri Tajchner, Henryk Tauber, Sima Vaïsman, Simone Veil nata Jacob, Rudolf Vrba, Robert Weil, Georges Wellers…
Tra gli ultimi arrivati, citiamo anche il caso clamoroso del clarinettista Binjamin Wilkomirski. Non si sa bene perché, questo falso testimone è stato pubblicamente smascherato dopo tre anni di una gloria che gli era valsa, negli Stati Uniti, il National Jewish Book Award; in Gran Bretagna, il Jewish Quarterly Literary Prize; in Francia, il premio Mémoire de la Shoah, nonché un’impressionante serie d’articoli ditirambici sulla stampa di tutto il mondo. La sua pretesa autobiografia di bambino deportato a Majdanek e ad Auschwitz (?) era uscita da Suhrkampf nel 1995 con il titolo di: Bruchstücke. Aus einer Kindheit, 1939 bis 1948 (Frantumi. Un’infanzia. 1939-1948, Mondadori, 1998). In Francia il libro era stato pubblicato da Calmann-Lévy nel 1997 con il titolo Fragments d’une enfance, 1939-1948. Al termine della sua inchiesta, un autore ebreo, Daniel Ganzfried, rivelava che Binjamin Wilkomirski, alias Bruno Doessekker, nato Bruno Grosjean, aveva di certo conosciuto Auschwitz e Majdanek ma solo dopo la guerra, da turista[24]. Nel 1995 l’Australiano Donald Watt aveva, anche lui, tratto in inganno i grandi media di lingua inglese con la sua pretesa testimonianza di «autista» dei crematori II e III di Auschwitz–Birkenau[25]. Nel settembre-novembre 1998, in Germania ed in Francia, si organizzava anche una vasta operazione mediatica attorno a delle improvvise «rivelazioni» del Dr. Hans Wilhelm Münch, ex-medico SS di Auschwitz. La vena è proprio inesauribile.
Primo Levi, dal canto suo, tende ad esserci presentato ancora oggi come un testimone degno di fede. Si vedrà nella presente opera che questa reputazione era forse meritata nel 1947 all’uscita del suo libro Se questo è un uomo; purtroppo, P. Levi l’ha, in seguito, demeritata. Elie Wiesel resta incontestabilmente «il grande testimone falso» dell’«Olocausto». Nell’opera La Notte, racconto autobiografico, egli non menziona le «camere a gas»; per lui, i Tedeschi gettavano gli ebrei in fornaci; addirittura il 2 giugno 1987, al processo Barbie, testimonierà sotto giuramento di aver «visto, in un boschetto, da qualche parte all’interno di [Auschwitz]-Birkenau, dei bambini vivi che alcune SS gettavano nelle fiamme». Nella presente opera, si noterà come il traduttore e l’editore della versione tedesca di La Notte abbiano resuscitato le «camere a gas» nel racconto di E. Wiesel. In Francia, Fred Sedel agirà allo stesso modo e metterà nel 1990, nella riedizione di un libro pubblicato nel 1963, delle «camere a gas» là dove non aveva menzionato, ventisette anni prima, che dei «forni crematori»[26].
Saranno ridotte nelle stesse condizioni di «pietose bugie» le testimonianze di certi non ebrei e, in particolare, del generale André Rogerie che, forte dell’appoggio che gli concedeva Georges Wellers, si presentava nel 1988 come «testimone dell’Olocausto» che aveva «assistito alla Shoah a Birkenau»[27] mentre, nell’edizione originale delle sue memorie, Vivre, c’est vaincre, pubblicata nel 1946, egli diceva solamente di aver sentito parlare delle «camere a gas»[28]. Il nostro eroe godeva proprio nel campo di Auschwitz-Birkenau di una sorte privilegiata. Egli era insediato nel blocco dei caïd[29] ed ivi beneficiava di una «pacchia da re» di cui «conserva dei buoni ricordi»[30]. Lì mangiava crêpe alla marmellata e giocava a bridge[31]. Certo, scriveva, «[nel campo] non accadono solo fatti allegri»[32]. ma, al momento di lasciare Birkenau, ha quest’intuizione: «Contrariamente a molti altri, io lì sono stato meno infelice che da qualsiasi altra parte»[33].
Samuel Gringauz aveva passato la guerra nel ghetto di Kaunas (Lituania). Nel 1950, cioè in un periodo in cui ci si poteva ancora esprimere con una certa libertà sull’argomento, egli redigeva il bilancio della letteratura dei sopravvissuti della «grande catastrofe ebraica». Egli deplorava allora in questa letteratura i misfatti del «complesso iperstorico» (hyperhistorical complex) o complesso del soprappiù rispetto alla storia. Egli scriveva:
Si può descrivere il complesso iperstorico come giudeocentrico, lococentrico ed egocentrico. Esso non trova essenzialmente significato storico se non per dei problemi ebraici legati ad eventi locali, e ciò sotto l’aspetto di un’esperienza personale. È la ragione per cui, nella maggior parte dei ricordi e dei racconti, si ostentano una verbosità assurda, l’esagerazione dello scribacchino, gli effetti scenici, una presuntuosa inflazione dell’ego, una filosofia da dilettante, un lirismo preso a prestito, voci non verificate, distorsioni, attacchi di parte e discorsi pietosi[34].
Non si può far altro che sottoscrivere a questo giudizio che, formulato nel 1950, varrebbe oggi idealmente per un Claude Lanzmann o un Elie Wiesel. Per il «complesso iperstorico» di quest’ultimo, per il carattere «giudeocentrico, lococentrico ed egocentrico» dei suoi scritti, ci si potrà richiamare ai due volumi delle sue memorie: Tutti i fiumi vanno al mare (vol. 1), … e il mare non si riempie mai (vol. 2). Ci si renderà conto, d’altronde, che, lungi dall’essere stati sterminati, gli ebrei rumeno-ungheresi della sola cittadina di Sighet sono verosimilmente sopravvissuti in gran numero alla deportazione, in particolare verso Auschwitz, nel maggio-giugno 1944. Originario di questa città di Sighet, E. Wiesel ha subito la sorte comune. Dopo la guerra, il suo peregrinare l’ha portato in varie parti del mondo dove, per effetto di un susseguirsi di «miracoli», ha incontrato un numero stupefacente di parenti, di amici, di vecchi conoscenti o di altre persone di Sighet che erano sopravvissuti ad Auschwitz o all’«Olocausto».
PANORAMICA DI ALTRE MISTIFICAZIONI
DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Ancora altrettanto perplesse, le generazioni future si porranno delle domande identiche su molti altri miti della seconda guerra mondiale oltre a quello delle camere a gas naziste: oltre a quello del «sapone ebreo», delle pelli umane conciate, delle «teste rimpicciolite» e dei «furgoni a gas» menzionati in precedenza, citiamo i dissennati esperimenti medici attribuiti al dottor Mengele, gli ordini di Adolf Hitler per intraprendere lo sterminio degli ebrei, l’ordine di Heinrich Himmler per far cessare questo sterminio, gli stermini di ebrei per mezzo dell’elettricità, del vapore acqueo, con l’impiego della calce viva, in forni crematori, in fosse di cremazione, con pompe a vuoto; citiamo anche il preteso sterminio degli zingari e degli omosessuali o la pretesa gassazione degli alienati mentali.
Quelle generazioni future s’interrogheranno su molti altri argomenti: i massacri sul fronte dell’Est come riferiti per iscritto, e solo per iscritto, al processo di Norimberga dal falso testimone professionista Hermann Gräbe; le imposture ora appurate come il libro Hitler m’a dit, firmato da Hermann Rauschning, dovuto, in gran parte, all’ebreo ungherese Imre Révész, alias Emery Reves, eppure abbondantemente utilizzato al processo di Norimberga come se fosse stato autentico; la possibile sperimentazione di una bomba atomica per eliminare degli ebrei vicino ad Auschwitz, menzionata al processo di Norimberga; le «confessioni» aberranti estorte a prigionieri tedeschi; il preteso diario di Anna Frank; il ragazzino del ghetto di Varsavia presentato come se andasse alla morte mentre è verosimilmente emigrato a New York dopo la guerra; e tanti falsi memoriali, falsi racconti, false testimonianze, false attribuzioni di cui, con un minimo d’attenzione, era facile individuare la vera natura.
Ma è probabile che quelle stesse future generazioni si stupiranno soprattutto del mito instaurato e reso sacro dal processo di Norimberga (e, in misura minore, dal processo di Tokyo): quello dell’intrinseca barbarie dei vinti e dell’intrinseca virtù dei vincitori che pur tuttavia, a guardare da vicino, hanno commesso degli orrori ben più notevoli, in fatto di qualità come di quantità, di quelli perpetrati dai vinti.
UNA CARNEFICINA UNIVERSALE
Nel momento in cui si finisca per credere che solo gli ebrei hanno davvero sofferto durante la seconda guerra mondiale e che solo i Tedeschi si sono comportati da veri e propri criminali, è d’uopo ritornare sulle vere sofferenze e i veri e propri crimini di tutti i belligeranti.
«Giusta» o «ingiusta», ogni guerra è una carneficina e persino una gara di carneficina, e ciò nonostante l’eroismo di molti combattenti; sicché alla fine del conflitto il vincitore non è più altro che un buon carnefice, e il vinto, un cattivo carnefice. Il vincitore può allora infliggere al vinto una lezione di carneficina ma non dovrebbe essere autorizzato ad impartirgli una lezione di diritto o di giustizia. È pur tuttavia ciò che al processo di Norimberga (1945-1946) i quattro grandi vincitori, agendo a nome loro e in nome di diciannove potenze vittoriose (senza contare il Congresso mondiale ebraico che beneficiava dello status di amicus curiae, cioè di «amico della corte»), hanno avuto il cinismo di fare nei confronti di un vinto ridotto ad una totale impotenza.
Secondo Nahum Goldmann, presidente del Congresso mondiale ebraico e presidente dell’Organizzazione sionista mondiale, l’idea del processo è uscita dritto dritto da alcuni cervelli ebrei[35]. Quanto al ruolo degli ebrei nel processo stesso di Norimberga, esso è stato considerevole. La delegazione americana, che conduceva tutto l’affare, era largamente composta da «reimmigranti», cioè da ebrei che, dopo aver lasciato la Germania negli anni ’30 per emigrare negli Stati Uniti, erano ritornati in Germania. Il famoso psicologo G. M. Gilbert, autore di Nuremberg Diary (1947), che lavorava sotto banco con il pubblico ministero americano, era ebreo e non perdeva l’occasione, a modo suo, per praticare la tortura psicologica sugli accusati tedeschi. In un libro che reca la prefazione di Lord Justice Birkett, membro del collegio giudicante, Airey Neave, addetto alla delegazione britannica, constatava che gli inquirenti americani erano «in gran parte tedeschi di nascita e tutti d’origine ebraica»[36].
Per delle ragioni che mi si vedrà esporre nella presente opera, si può ritenere che in questo secolo il processo di Norimberga sia stato il crimine dei crimini. Le sue conseguenze si sono rivelate tragiche. Esso ha accreditato una somma esorbitante di menzogne, di calunnie e d’ingiustizie che, a loro volta, sono servite a giustificare abomini d’ogni tipo, a cominciare dai crimini dell’espansionismo bolscevico o sionista a spese dei popoli d’Europa, d’Asia e della Palestina.
Ma, siccome i giudici di Norimberga hanno, in primo luogo e prima di tutto, condannato la Germania per la sua responsabilità unilaterale nel preparare e scatenare la seconda guerra mondiale, è questo punto che dobbiamo esaminare per primo.
QUATTRO GIGANTI E TRE NANI: CHI HA VOLUTO LA GUERRA?
Poiché la storia è in primo luogo un fatto di geografia, consideriamo un planisfero dell’anno 1939 e segniamo su di esso con un solo colore quattro immensi blocchi: la Gran Bretagna con il suo impero che occupava un quinto del globo «sul quale non tramontava mai il sole», la Francia con il suo vasto impero coloniale, gli Stati Uniti e i loro vassalli e, infine, l’impressionante impero dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; poi, con un altro colore, segniamo la modesta Germania entro le sue frontiere d’anteguerra, l’esile Italia ed il suo piccolo impero coloniale e, infine, il Giappone i cui eserciti, a quel tempo, occupavano una parte del territorio cinese. Lasciamo da parte i paesi che si sarebbero schierati, almeno provvisoriamente, a fianco dell’uno o dell’altro di questi due gruppi di belligeranti.
Il contrasto, per quanto riguarda questi due gruppi, colpisce in primo luogo dal punto di vista della superficie, poi da quello delle risorse naturali, industriali e commerciali. Certo, alla fine degli anni ’30, la Germania e il Giappone cominciavano – come lo dimostrerebbe il dopoguerra – a scuotere il giogo e a forgiarsi un’economia e un esercito capaci d’inquietare delle nazioni più grandi e più forti di loro. Certo, i Tedeschi e i Giapponesi dispiegavano una somma d’energia non comune e, durante i primi anni di guerra, conquistavano degli effimeri imperi. Ma, considerando il tutto, la Germania, l’Italia e il Giappone non erano, per così dire, che dei nani paragonati a quei quattro giganti che erano gli imperi britannico, francese, americano e sovietico.
A chi si farà credere che alla fine degli anni ’30 i tre nani cercassero deliberatamente, come si è preteso al processo di Norimberga e al processo di Tokyo, di provocare una guerra mondiale? E chi oserà affermare che nel 1945, quando la battaglia è terminata, i quattro giganti avevano commesso meno orrori dei tre nani? Meglio: chi crederà per un solo istante che, nella carneficina generalizzata, il primo di questi tre nani (la Germania) si sia reso colpevole di tutti i crimini possibili ed immaginabili mentre il secondo (il Giappone) è rimasto assai indietro rispetto al primo e il terzo (l’Italia), passato nel settembre 1943 all’altro campo, non ha commesso alcun atto veramente reprensibile? Chi accetterà l’idea che i quattro giganti non hanno, per riprendere la terminologia di Norimberga, commesso alcun «crimine contro la pace», alcun «crimine di guerra» né alcun «crimine contro l’umanità» che abbia meritato, dopo il 1945, di essere giudicato da un tribunale internazionale?
Eppure è facile mostrare, con prove alla mano, che i vincitori hanno, in sei anni di guerra e in pochi anni del dopoguerra, accumulato più orrori dei vinti in fatto di massacri di prigionieri di guerra, di massacri di popolazioni civili, di deportazioni gigantesche, di saccheggi sistematici e d’esecuzioni sommarie o giudiziarie. Katyn, il Gulag, Dresda, Hiroshima, Nagasaki, la deportazione di 12-15 milioni di Tedeschi (dalla Prussia Orientale, dalla Pomerania, dalla Slesia, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall’Ungheria, dalla Romania, dalla Iugoslavia) in condizioni orribili, la consegna di milioni di Europei al Moloch sovietico, la più sanguinosa «epurazione» che abbia spazzato tutto un continente, era davvero così poca cosa che nessun tribunale dovesse giudicare in proposito? In questo secolo, nessun esercito avrà ucciso tanti bambini quanti ne ha uccisi la US Air Force in Europa, in Giappone, in Corea, in Vietnam, in Iraq, in America Centrale e, pur tuttavia, nessuna giurisdizione internazionale le ha chiesto di rendere conto di questi massacri, che i suoi «boys» sono sempre pronti a scatenare un’altra volta in qualunque punto del globo, perché questo è il loro «job».
VOLEVANO FORSE LA GUERRA I FRANCESI?
«Sia maledetta la guerra!» reca scritto il monumento ai caduti del comune di Gentioux nel dipartimento della Creuse. Il monumento di Saint-Martin-d’Estréaux, nel dipartimento della Loira, è più prolisso, ma il suo «Bilancio della guerra» lancia lo stesso grido[37]. In Francia, nelle nostre chiese o sui nostri monumenti pubblici, l’elenco dei morti della guerra 1914-1918 fa venire il crepacuore. Oggi, nessuno, in fondo, è più in grado di dire per quale ragione di preciso la gioventù francese (proprio come, da parte sua, la gioventù tedesca) è stata così falcidiata.
Sugli stessi monumenti dei nostri comuni figurano a volte, in numero sensibilmente ridotto, i nomi di giovani Francesi caduti o dispersi durante la campagna 1939-1940: circa 87.000. A volte vi si leggono anche nomi di vittime civili; gli Anglo-Americani, da soli, hanno ucciso nei loro bombardamenti circa 67.000 Francesi. A volte ancora vi si leggono nomi di membri della resistenza, includendo qualche volta, per far numero, i nomi di membri della resistenza deceduti parecchio tempo dopo la guerra nel loro letto. Mancano, quasi dappertutto e quasi sempre, i nomi di Francesi vittime dell’«epurazione» (probabilmente 14.000 e non 30.000 o addirittura, come si è detto a volte, 105.000) in cui gli ebrei, i comunisti e i gollisti dell’ultima ora hanno avuto un ruolo fondamentale. Salvo eccezioni, mancano anche, perché non appartenevano per nascita a questi comuni, i membri delle truppe coloniali «morti per la Francia».
Per la Francia, le due guerre mondiali hanno costituito un disastro: la prima per il numero di perdite in vite umane e la seconda per il suo carattere di guerra civile che si perpetua ancora oggi.
A guardare questi elenchi dei caduti della prima guerra mondiale, a completarli con i nomi dei dispersi, a rammentare gli interi battaglioni di «volti sfigurati», di feriti, di mutilati, d’invalidi permanenti, a fare il conto delle distruzioni di ogni sorta, a pensare alle famiglie devastate da queste perdite, ai prigionieri, ai «fucilati per diserzione», ai suicidi provocati da tante prove, a rammentare anche i venticinque milioni di morti provocati in America e in Europa a partire dal 1918 da un’epidemia d’influenza impropriamente chiamata «spagnola» e importata in Francia, almeno in parte, dai soldati americani[38], non si possono forse capire sia i pacifisti e i fautori di «Monaco» ante 1939-1945 che i sostenitori del maresciallo Pétain del giugno 1940? Con quale diritto, oggi, si parla spesso e volentieri di vigliaccheria sia a proposito degli accordi di Monaco, conclusi il 29 e 30 settembre 1938, che dell’armistizio firmato a Rethondes il 22 giugno 1940? I Francesi che, a quel tempo, portavano ancora, nella carne o nello spirito, i segni dell’olocausto del 1914-1918 e dei suoi strascichi immediati – un vero e proprio olocausto, quello – potevano forse, alla fine degli anni ’30, concepire come un obbligo morale di doversi lanciare in una nuova carneficina? E, dopo la firma di un armistizio che, per quanto duro fosse, non aveva niente d’infamante, che cosa c’era di disonorevole nel ricercare l’intesa con l’avversario, non per fare la guerra ma per concludere la pace?
VOLEVANO FORSE LA GUERRA I TEDESCHI?
«Hitler [è] nato a Versailles»: la formula è servita come titolo ad un’opera di Léon Degrelle. Il diktat di Versailles – perché non ci fu veramente un trattato – fu, nel 1919, tanto rigoroso e così infamante per il vinto che i senatori americani rifiutarono di riconoscerlo (20 novembre 1919) e che cadde a poco a poco nel discredito. Esso smembrava la Germania, la sottoponeva ad una spietata occupazione militare, l’affamava. In particolare, esso obbligava il vinto a cedere alla Polonia la Posnania, la Slesia ed una parte della Prussia Occidentale. I quattrocentoquaranta articoli del «Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e la Germania» (nonché gli allegati) firmati a Versailles il 28 giugno 1919 costituiscono, con i trattati connessi, un monumento d’iniquità che solo il furore di una guerra appena terminata può, al limite, spiegare. «Si ha un bel rimproverare ai Tedeschi di non aver rispettato Versailles. Il loro dovere ed il loro senso dell’onore di Tedeschi imponevano d’aggirarlo prima, e poi di stracciarlo, così come il dovere e il senso dell’onore dei Francesi imponevano di mantenerlo»[39].
Vent’anni dopo la schiacciante umiliazione, Hitler vorrà ricuperare una parte dei territori consegnati alla Polonia, così come la Francia, dopo la disfatta del 1870, aveva voluto ricuperare l’Alsazia e una parte della Lorena.
Siccome nessuno storico è in grado – salvo dar prova di leggerezza – di designare il responsabile principale di un conflitto mondiale, ci si guarderà dal far portare a Hitler l’esclusiva responsabilità della guerra 1939-1945 con il pretesto che, il 1° settembre 1939, egli è entrato in guerra contro la Polonia. Invece, giustificare l’entrata in guerra, due giorni dopo, della Gran Bretagna e della Francia contro la Germania con la necessità, in nome di un trattato, di soccorrere la Polonia non ha molto senso, poiché, due settimane dopo, l’URSS entrava a sua volta in guerra contro la Polonia per occuparne una buona parte, senza provocare per questo alcuna reazione militare da parte degli Alleati.
I conflitti mondiali assomigliano a quelle gigantesche calamità naturali che non si possono predire esattamente nemmeno se, qualche volta, si sentono venire. Non si spiegano se non dopo, laboriosamente e non senza mostrare una soverchia malafede nelle accuse reciproche di negligenza, di cecità, di cattiva volontà o d’irresponsabilità.
Si può tuttavia costatare che in Germania, alla fine degli anni ’30, il partito della guerra con l’Occidente era per così dire inesistente; i Tedeschi non concepivano, per male che andasse, altro che una «spinta verso Est» (Drang nach Osten). In compenso, in Occidente, il partito della guerra con la Germania era potente. La «consorteria della guerra» volle «la crociata delle democrazie», e la ottenne.
Tra questi nuovi crociati figuravano in prima fila, salvo qualche notevole eccezione, gli ebrei americani ed europei congiuntamente.
WINSTON CHURCHILL E I BRITANNICI
QUALI PADRONI DELLA PROPAGANDA DI GUERRA
Durante la prima guerra mondiale, i Britannici avevano, con cinismo, sfruttato tutte le risorse della propaganda a base di racconti d’atrocità interamente fantasiose. Durante la seconda guerra mondiale essi non hanno derogato a tale consuetudine.
Oggi si è severi verso la politica di «pacificazione» condotta da Neville Chamberlain nei confronti dei Tedeschi e si ammira, o si finge di ammirare, Winston Churchill per la sua determinazione nel proseguire la guerra. Non è detto che la storia, con il tempo, mantenga questo giudizio. Ciò che si scopre a poco a poco della personalità e del ruolo di Churchill porta ad interrogarsi sui motivi piuttosto dubbi di questa determinazione e sui frutti della sua politica. Almeno Chamberlain aveva previsto che persino una vittoria della Gran Bretagna si sarebbe tramutata in disastro per la nazione stessa, per il suo impero ed anche per altri vincitori. Churchill non lo vide o non seppe vederlo. Egli annunciava il sudore, le lacrime, il sangue, e poi la vittoria. Egli non prevedeva i futuri giorni amari della vittoria: la rapida scomparsa di quell’impero britannico al quale egli teneva e la consegna di quasi metà dell’Europa all’imperialismo comunista.
In una delle sue conferenze, David Irving, biografo di Churchill, mostra il carattere illusorio dei successivi motivi che Churchill fu indotto ad invocare, prima per lanciare i suoi compatrioti nella guerra, poi per mantenerveli.
L’affare, se si può dire, si svolse in quattro tempi.
In un primo tempo, Churchill assicurò ai Britannici che era loro dovere venire in aiuto alla Polonia aggredita da Hitler, ma, due settimane dopo, questo motivo diventava caduco con l’aggressione della Polonia da parte dell’Unione Sovietica.
In un secondo tempo, egli spiegò ai suoi connazionali che essi dovevano continuare la guerra per salvaguardare l’impero britannico: egli rifiutava le reiterate offerte di pace della Germania; nel maggio 1941, egli faceva internare il messaggero di pace Rudolf Hess; e, mentre la Germania era incline al mantenimento dell’impero britannico, egli scelse di concludere un’alleanza con il nemico peggiore che ci fosse di quest’impero: l’Americano Franklin Roosevelt. Il secondo motivo diventava così caduco a sua volta.
In un terzo tempo, Churchill annunciò ai suoi compatrioti che essi dovevano battersi per la democrazia, anche sotto la sua forma più paradossale: la democrazia socialista sovietica; bisognava, egli diceva, aprire un secondo fronte in Europa per alleviare gli sforzi di Stalin. Equivaleva a venire in aiuto ad una dittatura che aveva pur tuttavia aggredito la Polonia il 17 settembre 1939 e che si apprestava ad una nuova conquista di questo paese.
Ancora un mese prima della fine della guerra in Europa (8 maggio 1945) la propaganda inglese girava così a vuoto, mentre molti soldati britannici e americani scoprivano con sgomento a che punto l’aviazione anglo-americana aveva devastato la Germania.
È allora che, all’improvviso, nell’aprile 1945, si produsse un miracolo che permise a Churchill di trovare questa volta il quarto e buon motivo: la scoperta del campo di Bergen-Belsen lo indusse a pretendere che, se la Gran Bretagna si era tanto battuta ed aveva provocato e subito tante distruzioni per quasi sei anni, non era stato per niente di meno che per la civiltà. Sicuramente, Churchill aveva già, più d’una volta, propinato ai Britannici le consuete tiritere, dalla guerra del 1914-1918, sulla Gran Bretagna, questa culla della civiltà messa in pericolo dalle orde teutoniche («dagli Unni», diceva), ma il meccanismo oratorio girava a vuoto. Il miracolo fu la scoperta nell’aprile 1945 di questo campo di concentramento devastato dalle epidemie: una manna per Churchill e per la propaganda britannica.
I BRITANNICI INAUGURANO A BERGEN-BELSEN
I REALITY SHOW DEI «CRIMINI NAZISTI»
(aprile 1945)
Situato vicino a Hannover, Bergen-Belsen era stato prima un campo per feriti di guerra tedeschi. Nel 1943, i Tedeschi vi stabilirono un campo di detenzione per ebrei europei da scambiare con civili tedeschi detenuti dagli Alleati. In piena guerra, degli ebrei furono trasferiti da questo campo verso la Svizzera o persino verso la Palestina attraverso la Turchia (prova supplementare, sia detto per inciso, dell’assenza di qualsiasi politica di sterminio fisico degli ebrei).
Fino alla fine del 1944, le condizioni di vita dei detenuti di Bergen-Belsen furono quasi normali, quando, con l’arrivo di convogli di deportati venuti dall’Est di fronte all’assalto sovietico, le epidemie di dissenteria, di colera e di tifo esantematico provocarono un disastro aggravato dai bombardamenti anglo-americani che impedivano l’arrivo dei medicinali, del cibo e – fu il colpo di grazia – dell’acqua. I convogli in arrivo non impiegavano più due o tre giorni per venire dall’Est, bensì da una a due settimane; a causa dei bombardamenti e dei mitragliamenti dell’aviazione alleata, essi non potevano circolare che di notte; il risultato fu che al loro arrivo questi convogli non contenevano più quasi nient’altro che dei morti, dei moribondi o un gran numero di uomini e donne stremati e dunque non in grado di affrontare tali epidemie. Il 1° marzo 1945, il comandante del campo, Josef Kramer, indirizzò al generale Richard Glücks, responsabile dei campi di concentramento, una lettera che descriveva in termini testuali questa «catastrofe» e terminava con «Imploro il Suo aiuto per superare questa situazione»[40].
La Germania, allo stremo delle forze, non poteva far fronte all’afflusso dei propri profughi dall’Est che giungevano a milioni. Essa non riusciva più ad approvvigionare l’esercito d’armi e munizioni e la popolazione di cibo. Infine, non poteva più porre rimedio alle drammatiche condizioni di vita dei campi dove persino i guardiani morivano a volte di tifo. Himmler autorizzò dei responsabili della Wehrmacht a prendere contatto con i Britannici per avvertire questi ultimi del fatto che si stavano avvicinando, nella loro avanzata, ad un temibile focolaio d’infezione. Ne seguirono dei negoziati. In un’ampia zona attorno a Bergen-Belsen fu dichiarata la tregua e Britannici e membri della Wehrmacht decisero, di comune accordo, di dividersi la sorveglianza del campo.
Ma lo spettacolo che scoprirono i Britannici e l’odore insopportabile dei cadaveri in decomposizione, nonché delle baracche o delle tende inondate di materia fecale finirono per sollevare l’indignazione generale. Si credette o si lasciò credere che le SS avevano deliberatamente scelto di uccidere o di lasciar morire i detenuti. E, nonostante i loro sforzi, i Britannici furono incapaci di arginare la spaventosa mortalità.
Come un nugolo d’avvoltoi, i giornalisti piombarono sul campo e filmarono o fotografarono tutti gli orrori possibili. Essi procedettero, per giunta, a dei montaggi. Una scena famosa, ripresa in Nuit et Brouillard, mostra un bulldozer che spinge dei cadaveri in una fossa comune. Molti spettatori di questa scena furono indotti a credere che si trattasse di «bulldozer tedeschi»[41]. Essi non si accorsero che il bulldozer (al singolare) era guidato da un soldato britannico che, probabilmente, dopo il conteggio dei cadaveri, li spingeva in una vasta fossa scavata dopo la liberazione del campo.
Ancora nel 1978, una pubblicazione ebraica mostrerà questo bulldozer ma non senza decapitarne, opportunamente, nella fotografia il guidatore in modo da nascondere il suo berretto di soldato inglese[42].

L’ebreo Sydney Lewis Bernstein, responsabile, a Londra, della sezione cinematografica del ministero dell’Informazione, fece appello ad Alfred Hitchcock per produrre un film su queste «atrocità naziste». In fin dei conti, furono resi pubblici solo degli spezzoni di questo film, probabilmente perché il film nella versione integrale conteneva delle asserzioni capaci di far dubitare della sua autenticità[43].
Ma nell’insieme, il «colpo di Bergen-Belsen» costituì una straordinaria riuscita per la propaganda degli Alleati. È a partire da questa prodezza mediatica che tutto il mondo imparò a non vedere ciò che aveva sotto gli occhi: gli si presentarono sia dei morti, sia dei moribondi ma il commento lo portò a credere di avere sotto gli occhi dei morti ammazzati, dei morti assassinati, degli sterminati, ovvero dei cadaveri ambulanti condannati a morire vittime d’uccisioni, d’assassini, di stermini. Così, come si è visto in precedenza, è a partire da un campo che non possedeva né forni crematori, né – secondo il parere stesso degli storici conformisti – la minima camera a gas omicida, che si edificò il mito generale della presenza ad Auschwitz ed altrove di «camere a gas» accoppiate con dei forni crematori.
In questo campo, tra le vittime più celebri delle epidemie si trovarono Anna Frank e sua sorella Margot che, per quasi quarant’anni dopo la guerra, si persisterà generalmente a presentare come gassate ad Auschwitz (campo da cui esse effettivamente provenivano) o come morte ammazzate a Bergen-Belsen; oggi, si è d’accordo nel riconoscere che esse sono morte di tifo a Bergen-Belsen nel febbraio-marzo 1945.
Il «colpo di Bergen-Belsen» fu ben presto imitato dagli Americani che, facendo appello a Hollywood, girarono una serie di film sulla liberazione dei campi tedeschi; essi procedettero ad una selezione di loro riprese cinematografiche (6.000 piedi di pellicola su un totale di 80.000, cioè 1.800 metri soltanto su quasi 25.000) che, il 29 novembre 1945, fu proiettata al processo di Norimberga dove tutti, compresa la maggior parte degli imputati, ne rimasero scossi. Alcuni imputati fiutarono l’imbroglio ma era troppo tardi: il bulldozer della grande menzogna era stato messo in moto. Esso è in funzione ancora oggi. Gli spettatori di tutti questi film d’orrore sui «campi nazisti» furono, alla lunga, condizionati dalla scelta delle immagini e dal commento. Un pezzo di muro, un mucchio di scarpe, un camino: non ebbero bisogno d’altro per credere che fosse stato mostrato loro un mattatoio chimico.
Cinquantadue anni dopo la liberazione del campo di Bergen-Belsen, Maurice Druon, segretario a vita dell’Académie française, verrà a deporre al processo di Maurice Papon. Ecco uno stralcio di questa deposizione in cui sono evocate le camere a gas omicide di Bergen-Belsen (di cui tutti gli storici riconoscono oggi che questo campo era privo), il famoso bulldozer e i «capelli tosati sui morti per farne un qualche surrogato»:
Quando oggi si parla dei campi si hanno negli occhi, e i giurati presenti hanno negli occhi quelle immagini atroci che i film e gli schermi ci presentano e ci ripresentano; e si ha ben ragione di farlo, e si dovrebbe diffonderli di nuovo in tutte le ultime classi, ogni anno. Ma quelle immagini, delle camere a gas, dei mucchi di capelli tosati sui morti per farne qualche surrogato, di quei bambini che giocavano tra i cadaveri, e di quei cadaveri così numerosi che si era costretti a spingerli nelle fosse con il bulldozer, e di quelle coorti scheletriche, titubanti e stralunate, in pigiama a righe, con la morte negli occhi, quelle immagini, e ne fornisco qui la testimonianza, io fui, nella mia modesta qualità di ufficiale d’informazione, uno dei venti ufficiali alleati che «ne presero visione» per primi, quando pervenne il materiale cinematografico integrale, come si dice, della liberazione da parte degli Inglesi del campo di Bergen-Belsen. Ma era la primavera del 1945. Fino a quel momento non si sapeva. – Non bisogna giudicare con i nostri occhi addestrati [sic] di oggi, ma con i nostri occhi accecati di ieri[44].
M. Druon, in realtà, aveva ieri degli «occhi addestrati» e oggi ha degli «occhi accecati». Più di cinquant’anni di propaganda l’hanno reso definitivamente cieco. Ma già durante la guerra, M. Druon e suo zio Joseph Kessel, entrambi ebrei, non erano forse accecati dall’odio verso il soldato tedesco quando componevano l’atroce Chant des Partisans («Uccisori con le pallottole o con il coltello, uccidete in fretta!»)?
AMERICANI E SOVIETICI RINCARANO
LA DOSE RISPETTO AI BRITANNICI
Almeno, nel 1951, un’ebrea come Hannah Arendt aveva l’onestà di scrivere: «Non è di poca importanza sapere che tutte le fotografie di campi di concentramento sono ingannevoli (misleading) nella misura in cui esse mostrano i campi nel loro ultimo periodo, nel momento in cui gli Alleati vi penetrarono […]. Le condizioni che regnavano nei campi risultavano dai fatti di guerra degli ultimi mesi: Himmler aveva ordinato l’evacuazione di tutti i campi di sterminio dell’Est; di conseguenza, i campi tedeschi furono notevolmente sovraffollati e non [si] era più in grado di garantire l’approvvigionamento in Germania»[45]. Ricordiamo qui, ancora una volta, che l’espressione «campi di sterminio» (extermination camps) è una creazione della propaganda di guerra alleata.
Eisenhower seguì le orme di Churchill e procedette, su scala americana, ad una tale propaganda a base di racconti d’atrocità che tutto divenne permesso sia nei riguardi del vinto che nei confronti della semplice verità dei fatti. Nei pretesi reportage sui campi tedeschi si aggiunsero, come ho detto, agli orrori veri degli orrori più veri del naturale. Si eliminarono le fotografie o gli spezzoni di film che mostravano degli internati dall’aspetto fiorente come quello di Marcel Paul, o ancora degli internati relativamente in buona salute nonostante la carestia o le epidemie, o ancora, come a Dachau, delle madri ebree ungheresi in buona salute che davano il biberon a dei bei pupi. Non si ricordarono che i derelitti, gl’invalidi, i relitti umani che erano, in realtà, vittime tanto dei Tedeschi quanto degli Alleati che, con i loro bombardamenti a tappeto su tutta la Germania e i loro mitragliamenti sistematici dei civili, anche dei contadini nei loro campi, avevano creato una situazione apocalittica proprio nel cuore dell’Europa.
La verità obbliga a dire che né Churchill, né Eisenhower, né Truman, né de Gaulle spinsero comunque l’impudenza fino ad avallare le storie di mattatoi chimici; essi lasciarono questa cura alle loro fucine di propaganda e ai giudici dei loro tribunali militari. Furono inflitte terribili torture ai Tedeschi colpevoli, agli occhi degli Alleati, di tutti questi «crimini»; furono esercitate delle rappresaglie sui prigionieri tedeschi e sui civili. Fino al 1951 si fucilarono e s’impiccarono Tedeschi e Tedesche (ancora negli anni ’80, i Sovietici fucileranno dei «criminali di guerra» tedeschi o alleati dei Tedeschi). I militari britannici ed americani, da principio sconvolti dallo spettacolo delle città tedesche ridotte in cenere e allo stesso tempo dei loro abitanti trasformati in trogloditi, poterono ritornare a casa con la coscienza tranquilla. Churchill e Eisenhower se ne facevano garanti: le truppe alleate avevano sgominato il Male; esse incarnavano il Bene; si sarebbe proceduto alla «rieducazione» del vinto bruciando i suoi cattivi libri a milioni. A conti fatti, la Grande Carneficina era stata condotta a buon fine e per il buon motivo.
È questo il bluff che il processo-spettacolo di Norimberga consacrò.
UN BLUFF FINALMENTE DENUNCIATO NEL 1995
Ci vollero non meno di cinquant’anni perché una storica, Annette Wieviorka, ed un cineasta, William Karel, rivelassero al grande pubblico, in un documentario intitolato Contre l’oubli, le messe in scena e le creazioni americane e sovietiche del 1945 in merito alla liberazione dei campi dell’Ovest e dell’Est.
A. Wieviorka, ebrea francese, e W. Karel, Israeliano residente in Francia dal 1985, hanno manifestamente subito l’influenza della scuola revisionista francese. Assai ostili ai revisionisti, essi hanno nondimeno ammesso che era giunto il momento di denunciare alcune invenzioni troppo vistose della propaganda sterminazionista. Al riguardo si farà riferimento sia ad un articolo di Philippe Cusin[46], sia, soprattutto, in occasione della nuova diffusione del documentario su Antenne 2, a un articolo di Béatrice Bocard il cui titolo, da solo, la dice lunga: «La Shoah, dalla realtà agli show. Di fronte ai racconti dei deportati, l’indecente messa in scena dei loro liberatori»[47]. La giornalista scrive:
Esagerando appena, si potrebbe dire che la liberazione dei campi di concentramento ha inaugurato i reality show […]. Le primizie della società dello spettacolo che le catene televisive come la CNN avrebbero banalizzato cinquant’anni dopo c’erano già, con il soprappiù dell’indecenza, del voyeurismo e il ricorso alla messa in scena […]. Davanti alle telecamere, si fa ripetere ai meno malandati dei sopravvissuti il loro testo: «Io sono stato deportato perché ero ebreo», dice uno. Una volta, due volte… […] Per non essere da meno dopo lo «show» americano, i Sovietici, che non avevano fatto niente al momento della liberazione di Auschwitz, filmano una «falsa liberazione» alcune settimane dopo, con delle comparse polacche che acclamano i soldati a gran voce… «William Karel è il primo a sfaldare queste false immagini che ci sono sempre state mostrate, anche assai di recente, come autentiche», dice Annette Wieviorka. Come si è potuto credervi? «Non c’è l’abitudine di mettere in dubbio le immagini come lo si fa per gli scritti», spiega la storica. «L’esempio del carnaio di Timisoara non è tanto remoto».
Va da sé che, in quest’articolo di B. Bocard, le manipolazioni erano mostrate come oltraggiose… per i deportati. Quanto ai Tedeschi, civili e militari, alcuni di loro avevano denunciato sin dal 1945 questo tipo di montaggi; ma, piuttosto che credere loro, li si accusò di nazismo o d’antisemitismo.
EMINENTE RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI
EBRAICHE IN QUESTA PROPAGANDA
Dalle sue origini, 1941, ai nostri giorni, la propaganda sviluppatasi attorno al «genocidio» o alle «camere a gas» è essenzialmente dovuta alle organizzazioni ebraiche. Perciò si è a poco a poco formata nel grande pubblico la convinzione che un’impresa di sterminio fisico condotta dai Tedeschi mirasse, prima di tutto, agli ebrei e che le «camere a gas» fossero in qualche modo riservate agli ebrei (compresi gli ebrei del Sonderkommando che conducevano i loro correligionari al mattatoio). Oggi, gli innumerevoli «musei dell’Olocausto» costituiscono un monopolio ebraico ed è una parola ebraica, la parola Shoah (catastrofe), che designa sempre più spesso questo preteso genocidio. Qualsiasi possa essere stata la loro partecipazione alla costruzione e al successo del mito, gli Alleati non hanno avuto in questa circostanza che un ruolo secondario e sempre sotto le pressioni delle organizzazioni ebraiche. Tuttavia, il caso dei Sovietici potrebbe essere stato diverso: la loro fabbricazione di un «Auschwitz» dove non viene messo l’accento sulla sorte degli ebrei potrebbe avere trovato origine nella necessità di una propaganda, al di là della Cortina di ferro, in direzione dei progressisti occidentali.
E non è perché oggi delle voci ebree si levano per chiedere che si parli meno delle «camere a gas», che la propaganda dell’«Olocausto» o della Shoah smorza il tono presso i responsabili della comunità israelitica. Più semplicemente, agli occhi degli storici ebrei, queste incredibili «camere a gas» sono diventate ingombranti per la propagazione della fede nella Shoah.
Una personalità politica francese ha detto delle camere a gas naziste che erano un dettaglio della seconda guerra mondiale. Ora, nelle loro rispettive opere su questa guerra, Eisenhower, Churchill e de Gaulle hanno apparentemente ritenuto che questi mattatoi chimici fossero addirittura meno di un dettaglio poiché non ne hanno fatto parola. Si nota la stessa discrezione nello storico René Rémond, importante membro del Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale prima, poi dell’Institut d’histoire du temps présent: in due sue opere dove ci si sarebbe aspettato di veder figurare le parole «camera a gas», non si trova niente di tale. Lo storico americano Daniel Jonah Goldhagen parla di queste camere come di un «epifenomeno». Nella versione francese della sentenza di Norimberga, vi sono dedicate solo 520 parole, estremamente vaghe, su circa 84.000, il che costituisce lo 0,62% del testo di questa sentenza.
Per un revisionista, le camere a gas sono meno di un dettaglio, perché molto semplicemente non sono esistite; ma il mito delle camere a gas, esso, è molto più di un dettaglio: è la pietra angolare d’un immenso edificio di credenze di ogni sorta che la legge ci vieta di contestare.
«Camere a gas o no, che importanza ha?» Si sente a volte questa domanda, impregnata di scetticismo. Essa irrita lo storico P. Vidal-Naquet per il quale rinunciare alle camere a gas equivarrebbe a «capitolare in aperta campagna»[48]. Non si può far altro che dargli ragione. Infatti, a seconda che le camere a gas siano esistite o no, ci verranno presentati i Tedeschi come dei criminali matricolati oppure gli ebrei come dei bugiardi matricolati (o imbonitori). Nel primo caso, i Tedeschi hanno, per tre o quattro anni, ucciso con mezzi industriali e in proporzioni industriali delle sventurate vittime inermi, mentre, nel secondo caso, gli ebrei, da più di mezzo secolo, propalano una menzogna di dimensioni storiche.
Nel 1976 l’universitario americano Arthur Robert Butz pubblicava la sua opera The Hoax of the Twentieth Century; da parte mia, io pubblicavo su Le Monde del 29 dicembre 1978 e del 16 gennaio 1979 due testi sulla «voce su Auschwitz» e, proprio all’inizio dello stesso anno 1979, Wilhelm Stäglich pubblicava Der Auschwitz Mythos. Facendosi portavoce di molte inquietudini ebraiche dinanzi al fiorire degli scritti revisionisti, il sionista William D. Rubinstein, professore all’università Deakin di Melbourne (Australia), scriveva allora:
Se si dimostrasse che l’Olocausto è una mistificazione, scomparirebbe l’arma n. 1 dell’arsenale della propaganda d’Israele[49].
Ripetendosi qualche tempo dopo, dichiarava:
[Sta] di fatto che, se si può dimostrare che l’Olocausto è un «mito sionista», crolla la più forte di tutte le armi dell’arsenale della propaganda d’Israele[50].
Otto anni dopo, come a fargli eco, un avvocato della LICRA dichiarava:
Se le camere a gas sono esistite, la barbarie nazista non eguaglia nessun’altra. Se non sono esistite, gli ebrei hanno mentito e l’antisemitismo si vedrebbe giustificato. Ecco la posta in gioco del dibattito[51].
Secondo la formula di E. Zündel, «l’«Olocausto» è la spada e lo scudo d’Israele».
La posta in gioco non è dunque semplicemente storica, bensì politica. Questa posta in gioco politica è paradossale: il mito dell’«Olocausto» serve a condannare in primo luogo il nazionalsocialismo tedesco, poi ogni forma di nazionalismo o d’idea nazionale salvo il nazionalismo israeliano e l’idea sionista che questo mito, al contrario, rafforza.
La posta in gioco è anche finanziaria quando si pensa che, almeno a partire dagli accordi sulle «riparazioni» firmati nella città di Lussemburgo nel 1952, i contribuenti tedeschi hanno versato delle somme «astronomiche» (l’aggettivo qualificativo è di Nahum Goldmann) agli ebrei dello Stato d’Israele o della Diaspora nel loro insieme e che continueranno, a causa della Shoah, a pagare per i crimini che si imputano loro almeno fino all’anno 2030. Lo «Shoah-Business», denunciato persino da un P. Vidal-Naquet, è indissociabile dalla Shoah.
Oggi, il bluff della Shoah autorizza un racket su scala mondiale. Per cominciare, una serie crescente di paesi ricchi o poveri, tra cui la Francia, si vedono reclamare, da parte del Congresso mondiale ebraico presieduto dal miliardario Edgar Bronfman e da parte di ricchissime organizzazioni ebraiche americane, montagne d’oro e di denaro a titolo di nuove «restituzioni» o di nuove «riparazioni». I paesi d’Europa, a cominciare dalla Svizzera, non sono i soli presi di mira. Per il momento, una mafia, saldamente insediata, opera in quattro direzioni principali (ce ne saranno altre, non c’è da dubitare): «l’oro nazista», gli averi degli ebrei, le collezioni d’arte ebree e le polizze d’assicurazione sottoscritte da ebrei. I bersagli principali sono i governi, le banche, i musei, le sale d’asta pubblica e le compagnie d’assicurazioni. Negli Stati Uniti, sotto le pressioni delle organizzazioni ebraiche, lo Stato del New Jersey ha già votato delle misure di boicottaggio contro le istituzioni bancarie svizzere. Non è che un inizio. La sola vera argomentazione invocata dai maestri cantori è racchiusa in una parola: Shoah. Non un governo, non una banca, non una società d’assicurazioni osa ribattere a sua difesa che si tratta qui di un mito e che non è il caso di pagare per un crimine che non è stato commesso. Gli Svizzeri, su pressioni delle organizzazione ebraiche, in un primo tempo hanno avuto l’ingenuità di votare una legge che vietava qualsiasi rimessa in discussione della Shoah; ma non hanno fatto in tempo a pubblicare questa legge che E. Bronfman ha presentato loro il conto da pagare. Gli Svizzeri hanno allora offerto delle somme considerevoli. Fatica sprecata. E. Bronfman, «in collera», ha fatto sapere che gli ci voleva infinitamente di più. «La mia esperienza degli Svizzeri – ha dichiarato – è che, a meno che non teniate loro i piedi sul fuoco, non vi prendono sul serio»[52].
Quanto al danno morale causato alla Germania in particolare e ai non ebrei in generale dalla propagazione della religione dell’«Olocausto», esso è incalcolabile. Le organizzazioni ebraiche non cessano di reiterare le loro accuse contro una Germania colpevole d’un «genocidio» degli ebrei e contro Churchill, Roosevelt, de Gaulle, Stalin, papa Pio XII, il Comitato internazionale della Croce Rossa, i paesi neutrali ed altri paesi ancora, colpevoli, pare, di aver lasciato che la Germania commettesse questo «genocidio» e debitori, di conseguenza, anch’essi, di «riparazioni» finanziarie.
LE ORGANIZZAZIONI EBRAICHE IMPONGONO
IL CREDO DELL’«OLOCAUSTO»
La mia opera, come si vedrà, tocca poco la «questione ebraica».
Se, per tanti lustri, ho perseguito con accanimento l’indagine storica senza preoccuparmi troppo della «questione ebraica» in quanto tale, è che, nella mia mente, quest’ultima non aveva che un’importanza secondaria. Essa rischiava di distogliermi dall’essenziale: io cercavo, in primo luogo e prima di tutto, di determinare le rispettive parti della verità e del mito nella storia detta dell’«Olocausto» o della Shoah; m’importava dunque molto di più di stabilire la materialità dei fatti che di ricercare le responsabilità.
Eppure, mio malgrado, due fatti mi costringevano ad uscire dalla mia riserva: l’atteggiamento di numerosi ebrei nei confronti dei miei lavori e la loro ingiunzione lancinante di dovermi pronunciare su ciò che appassiona tanti di loro: la «questione ebraica».
Quando, all’inizio degli anni ’60, abbordai ciò che Olga Wormser-Migot chiamava, nella sua tesi del 1968, «il problema delle camere a gas», io seppi di primo acchito quali conseguenze avrebbe potuto comportare una simile impresa. L’esempio di P. Rassinier mi avvertiva che potevo temere gravi ripercussioni. Decisi nondimeno di andare avanti, di attenermi ad una ricerca di carattere puramente storico e di pubblicarne il risultato. Sceglievo anche di lasciare all’eventuale avversario la responsabilità di uscire dal campo della controversia universitaria per impiegare i mezzi della coercizione e forse persino della violenza fisica.
È precisamente ciò che avvenne. Valendomi di un paragone, potrei dire che in qualche modo la fragile porta d’ufficio dietro alla quale redigevo i miei scritti revisionisti cedette, un giorno, sotto la spinta di una turba vociante di protestatari. Mi fu allora giocoforza constatarlo, la totalità o la quasi totalità degli agitatori erano figli e figlie d’Israele. «Gli ebrei» avevano appena fatto irruzione nella mia vita. Io li scoprivo all’improvviso non più quali li avevo conosciuti fino a quel momento, cioè come individui da distinguere gli uni dagli altri, ma come gli elementi, impossibili da staccare gli uni dagli altri, di un gruppo particolarmente saldato nell’odio e, per usare la loro parola, nella «collera». Frenetici, con la bava alla bocca, con tono di gemito e al tempo stesso di minaccia, essi venivano a strombazzarmi all’orecchio che i miei lavori li irritavano, che le mie conclusioni erano false e che dovevo tassativamente fare atto di vassallaggio alla loro interpretazione della storia della seconda guerra mondiale. Quest’interpretazione kasher pone «gli ebrei» al centro di questa guerra come vittime, non somiglianti a nessun’altra, di un conflitto che ha però causato probabilmente quasi quaranta milioni di morti. Per loro, il loro massacro era unico nella storia del mondo. Mi si avvertiva che, a meno di sottomettermi, avrei visto la mia carriera rovinata. Sarei stato trascinato dinanzi ai tribunali. Poi, per via mediatica, il Gran Sinedrio, formato dai sacerdoti, dai notabili e dai dottori della legge ebraica, lanciò contro la mia persona una virulenta campagna di richiami all’odio e alla violenza. Non mi dilungherò sul susseguirsi, interminabile, degli oltraggi, delle aggressioni fisiche e dei processi.
I responsabili di queste organizzazioni mi trattano volentieri da «nazista», che io non sono. Paragone per paragone, io sarei piuttosto, rispetto a loro, un «Palestinese», trattato come tale e portato a credere che nei riguardi di coloro che essi non gradiscono gli ebrei si comportano nella Diaspora come li si vede comportarsi in Palestina. I miei scritti sono, se si vuole, le pietre della mia Intifada. Parlando francamente, io non scopro nessuna differenza essenziale tra il comportamento dei responsabili sionisti di Tel-Aviv o di Gerusalemme e quello dei responsabili ebrei di Parigi o di New York: stessa durezza, stesso spirito di conquista e di dominio, stessi privilegi, su un fondo incessante di ricatto, di pressioni accompagnate da lagnanze e gemiti. Questo nello spazio. È forse altrimenti nel tempo? Il popolo ebraico è stato forse così sventurato nei secoli passati da essere pronto a dirlo? Ha forse sofferto di guerre e guerre civili tanto quanto le altre comunità umane? Ha forse conosciuto altrettante ristrettezze e miseria? Non ha davvero nessuna responsabilità nelle reazioni d’ostilità di cui si lamenta spesso e volentieri? Su questo punto, Bernard Lazare scrive:
Se quest’ostilità, addirittura questa ripugnanza, si fossero esercitate nei riguardi degli Ebrei solo in un periodo e solo in un paese, sarebbe facile individuare le cause ristrette di queste collere; ma questa razza è stata, al contrario, fatta segno all’odio da parte di tutti i popoli in mezzo ai quali si è stabilita. Bisogna dunque, poiché i nemici degli Ebrei appartenevano alle razze più diverse, vivevano in contrade molto lontane le une dalle altre, erano retti da leggi diverse, governati da principi opposti, non avevano né gli stessi usi, né gli stessi costumi, erano animati da spiriti dissimili che non permettevano loro di giudicare ugualmente tutte le cose, bisogna dunque che le cause generali dell’antisemitismo siano sempre risiedute in Israele stesso e non presso coloro che le combatterono.
Questo non per affermare che i persecutori degli Israeliti ebbero sempre il diritto dalla loro parte, né che essi non si lasciarono andare a tutti gli eccessi che comportano gli odi vivi, ma per porre come postulato che gli Ebrei furono causa – in parte almeno – dei propri mali[53].
B. Lazare, che non è per niente ostile ai suoi correligionari – ben al contrario –, ha la schiettezza di ricordare a più riprese quanto gli ebrei abbiano saputo, in tutto il corso della loro storia, sin dall’Antichità, guadagnarsi dei privilegi: «[Molti]tra la povera gente erano attirati dai privilegi concessi agli Ebrei»[54].
Mi si permetterà qui una confidenza.
Da vecchio latinista e al tempo stesso da imputato perseguito dinanzi ai tribunali da parte di organizzazioni ebraiche, da professore universitario cui si è impedito di tenere le proprie lezioni a causa di manifestazioni ebraiche, e, infine, da autore cui è stato vietato di pubblicare a causa di decisioni del rabbinato maggiore ratificate dalla repubblica francese, mi capita di confrontare le mie esperienze con quelle d’illustri predecessori. È così che penso all’aristocratico romano Lucio Flacco. Nel 59 prima della nostra era, Cicerone ebbe a difenderlo in particolare contro i suoi accusatori ebrei; la descrizione che fa l’illustre oratore dell’influenza, della potenza e dei procedimenti degli ebrei di Roma nel pretorio mi fa pensare che, se egli ritornasse sulla terra, nel XX secolo, per difendervi un revisionista, non avrebbe per così dire bisogno di cambiare neanche una parola su questo punto nella sua arringa del Pro Flacco.
Avendo dovuto insegnare alla Sorbona, penso anche al mio predecessore Henri Labroue, autore di un’opera su Voltaire antijuif. Alla fine del 1942, in piena occupazione tedesca, in un periodo in cui ci vogliono far credere che gli ebrei e i loro difensori si dimostrassero quanto più possibile discreti, egli dovette rinunciare a tenere le sue lezioni sulla storia del giudaismo. Citiamo André Kaspi:
È stata creata alla Sorbona una cattedra di storia del giudaismo per la ripresa delle lezioni dell’anno accademico 1942 e affidata a Henri Labroue. Le prime lezioni hanno dato luogo a manifestazioni d’ostilità e a incidenti che hanno comportato la soppressione dei corsi[55].
Ma, oggi, immancabilmente si ritroverebbero dinanzi ai tribunali, su querela di associazioni ebraiche, decine di grandi nomi della letteratura mondiale, tra cui Shakespeare, Voltaire, Hugo nonché Zola (il difensore di Dreyfus ha anche scritto L’Argent). Tra i grandi nomi della politica, persino un Jaurès siederebbe sul banco dell’infamia.
Tali considerazioni potrebbero valermi l’epiteto d’antisemita o d’antiebreo. Io respingo queste qualifiche che considero facili insulti. Io non voglio nessun male a nessun ebreo. Trovo, invece, detestabile il comportamento della maggior parte delle associazioni, organizzazioni e gruppi di pressione che pretendono di rappresentare gli interessi ebraici o la «memoria ebraica».
I responsabili di queste associazioni, organizzazioni o gruppi fanno manifestamente molta fatica a capire che si possa agire per semplice onestà intellettuale. Se, dal canto mio, ho dedicato buona parte della mia vita al revisionismo, prima nel campo degli studi letterari, poi in quello della ricerca storica, non è affatto in seguito ad odiosi calcoli o per servire un complotto antiebraico, ma per un moto così naturale come quello che fa sì che l’uccello canti, che spunti la foglia e che, nelle tenebre, l’uomo aspiri alla luce.
RESISTENZA NATURALE DELLA SCIENZA STORICA A QUESTO CREDO
Come certi altri revisionisti, avrei potuto operare la mia sottomissione, fare atto di pentimento, ritrattare; altra scappatoia: mi sarei potuto accontentare di ordire dei sapienti ed arzigogolati stratagemmi. Non soltanto io decisi, a cominciare dagli anni ’70, di resistere a viso aperto e alla luce del sole, ma mi ripromisi di non prendere parte al gioco dell’avversario. Io presi la risoluzione di non cambiare niente nel mio comportamento e di lasciare che gli eccitati si eccitassero ogni giorno di più. Tra gli ebrei, non avrei ascoltato che quelli, particolarmente coraggiosi, che osavano prendere le mie difese almeno nello spazio di una stagione[56].
Le organizzazioni ebraiche nell’insieme trattano come antisemiti coloro che non adottano la loro concezione della storia della seconda guerra mondiale. Le si può capire, poiché arrivare a dire, come faccio io qui ora, che esse rientrano, per me, nel novero dei principali responsabili della propagazione di un mito gigantesco ha le apparenze di un’opinione ispirata dall’antisemitismo. Ma, in realtà, io non faccio che trarre le conclusioni ovvie di un’indagine storica che, con ogni probabilità, deve essere tra le più serie, poiché nessun tribunale, nonostante le febbrili ricerche dell’accusa, ha potuto individuarvi tracce di leggerezza, di negligenza, di deliberata ignoranza o di menzogna.
Peraltro, a dei gruppi di persone che non hanno manifestato il minimo rispetto per le mie ricerche, le mie pubblicazioni, la mia vita personale, familiare o professionale, non vedo perché, dal canto mio, dovrei dimostrare rispetto. Io non attacco né critico questi gruppi per le loro convinzioni religiose o il loro attaccamento allo Stato d’Israele. Tutti i gruppi umani si beano di fantasmagorie. Di conseguenza, ciascuno di loro è libero di offrirsi della sua storia una rappresentazione più o meno reale, più o meno immaginaria. Ma questa rappresentazione, non bisogna imporla agli altri. Ora, le organizzazioni ebraiche c’impongono la loro, cosa che, in sé, è inaccettabile e lo è ancora di più quando questa rappresentazione è manifestamente erronea. Ed io non conosco in Francia nessun gruppo che, di un articolo di fede della sua religione (quella della Shoah) sia arrivato a fare un articolo della legge repubblicana; che benefici del privilegio esorbitante di possedere delle milizie armate con l’assenso del ministero dell’Interno; e che, infine, possa decretare che gli universitari che non gli sono graditi non avranno più diritto d’insegnare né in Francia, né all’estero (vedi, in particolare, il caso Bernard Notin).
PER UN REVISIONISMO SENZA COMPLESSI
I revisionisti non conoscono in effetti né maestro né discepolo. Essi formano una truppa eteroclita. Ripugna loro organizzarsi, il che presenta tanti inconvenienti quanti vantaggi. Il loro individualismo li rende inadatti all’azione concertata; in compenso, i servizi di polizia si rivelano incapaci di penetrare e di sorvegliare un insieme così disparato; essi non possono risalire a nessun canale, proprio perché non esiste nessuna rete revisionista. Questi individui si sentono liberi d’improvvisare, ognuno secondo le proprie attitudini o i propri gusti, un’attività revisionista che assumerà le forme più diverse. La qualità dei lavori intrapresi ne risente e bisogna riconoscere che il risultato è disuguale. Da questo punto di vista, si può dire che resta ancora molto da fare. Il semplice dilettante sta gomito a gomito con l’erudito, e l’uomo d’azione con il ricercatore nei suoi archivi. Io qui non farò nomi per timore di catalogare ciascuno di questi individui[57].
Sulla maniera di condurre la battaglia revisionista, va da sé che i revisionisti si dividono tra fautori ed avversari di una sorta di realismo politico. La maggior parte ritiene che, di fronte alla potenza del tabù, è meglio procedere per vie traverse e non scontrarsi frontalmente con i sostenitori dell’ortodossia. Per questi revisionisti, è maldestro ed imprudente buttare lì, per esempio, che l’«Olocausto» è un mito; è meglio, secondo loro, insinuare che l’«Olocausto» è esistito per davvero ma non nelle proporzioni generalmente ammesse. Presi dalla strategia o dalle tattiche, questi revisionisti cercheranno di aver riguardo per le suscettibilità ebraiche e suggeriranno, a torto, che la parte leggendaria dell’«Olocausto» è soprattutto imputabile ai comunisti o agli Alleati ma non agli ebrei, o comunque assai poco. Non si vedono forse degli apprendisti revisionisti praticare il fallace amalgama che consiste nel presentare gli ebrei come vittime, allo stesso titolo degli altri, di una sorta di credo universale erroneo? Gli ebrei si sarebbero visti obbligati, in qualche modo da una forza immanente, a credere al genocidio ed alle camere a gas, mentre, probabilmente, la stessa forza li spingerebbe a reclamare ancora più denaro in riparazione alle sofferenze fittizie[58]. A un ebreo errante appena passato al campo revisionista, si farà festa come al genio più puro del revisionismo. Se riprenderà a suo conto, ed in modo maldestro, le scoperte dei suoi predecessori non ebrei su Auschwitz, si saluterà in questo nuovo venuto un luminare del pensiero scientifico.
Io ammetto certe forme di questo realismo politico, ma a condizione che non sia accompagnato da arroganza. Non c’è nessuna superiorità, né intellettuale né morale, nel pensare che il fine giustifica i mezzi e che a volte bisogna proprio prendere a prestito dall’avversario le armi della dissimulazione e della menzogna. Ma, personalmente, la mia preferenza va ad un revisionismo senza complessi e senza troppi compromessi. Si dichiara il colore. Si cammina diritto verso la meta. Soli, se necessario. Non si ha riguardo per l’avversario. D’altronde, una lunghissima esperienza della battaglia revisionista mi fa pensare che la migliore strategia, la migliore tattica possano consistere in una successione di attacchi frontali; l’avversario non se li aspettava; egli immaginava che nessuno avrebbe avuto l’audacia di sfidarlo così; egli scopre di non fare più paura; ne è disorientato.
UN CONFLITTO SENZA FINE
I revisionisti hanno proposto cento volte ai loro avversari un dibattito pubblico sul genocidio, le camere a gas e i sei milioni. Le organizzazioni ebraiche si sono sempre sottratte a questa proposta. C’è ora la prova che esse non l’accetteranno. Almeno la Chiesa cattolica ammette oggi una forma di dialogo con gli atei, ma lei, la Sinagoga, non dimenticherà l’offesa fattale[59] e non si risolverà mai a correre il rischio di un tale dialogo con i revisionisti. Peraltro, sono in gioco troppi interessi politici, finanziari e morali perché, da parte loro, i responsabili dello Stato d’Israele o della Diaspora accettino di avviare un simile dibattito sulla versione kasher della storia della seconda guerra mondiale.
Continuerà dunque la prova di forza. Io non ne vedo una fine. Il conflitto al quale noi assistiamo tra «sterminazionismo» e «revisionismo», cioè, da un lato, una storia ufficiale, immutabile, sacra e, dall’altro, una storia critica, scientifica, profana, s’iscrive nella battaglia senza fine che si danno nelle società umane, da millenni, la fede e la ragione o le credenze e la scienza. La fede nell’«Olocausto» o Shoah fa parte integrante di una religione, la religione ebraica, di cui, a guardare da vicino, le fantasmagorie dell’«Olocausto» non sono che un’emanazione. Non si è mai vista una religione crollare sotto i colpi della ragione. Non sarà domani che scomparirà la religione ebraica con una delle sue componenti più vivaci. Secondo le interpretazioni in atto, questa religione è vecchia di 1.500 anni o di tremila, se non di quattromila anni. Non si vede perché gli uomini dell’anno 2000 dovrebbero beneficiare del privilegio d’assistere in diretta al naufragare di una religione che risale a tempi tanto antichi.
Si sente a volte dire che il mito dell’«Olocausto» o della Shoah potrebbe un giorno svanire come è crollato non molto tempo fa il comunismo stalinista o come crolleranno un giorno prossimo futuro il mito sionista e lo Stato d’Israele. Equivale a paragonare ciò che non è paragonabile. Comunismo e sionismo poggiano su basi fragili; tutt’e due presuppongono nell’uomo delle alte aspirazioni che sono largamente illusorie: il disinteresse generalizzato, la divisione alla pari tra tutti, il senso di sacrificio, il lavoro a profitto di tutti; i loro emblemi sono, in un caso, la falce, il martello e il kolchoz e, nell’altro, la spada, l’aratro e il kibbutz. La religione ebraica, da parte sua, sotto l’apparenza lambiccata della masora o del pilpul, non si perde in queste fantasticherie; essa mira basso per mirare giusto; essa fa assegnamento sul reale; sotto la copertura di stravaganze talmudiche e prestidigitazioni intellettuali o verbali, si vede che essa fa soprattutto lega con il denaro, il re dollaro, il Vitello d’Oro e le blandizie della società dei consumi. Chi può credere che quei valori perderanno un giorno prossimo futuro parte del loro potere? E, peraltro, in che modo la scomparsa dello Stato d’Israele provocherebbe conseguenze nefaste per il mito dell’«Olocausto»? Al contrario, milioni di ebrei, costretti a raggiungere i paesi ricchi dell’Occidente o a ritornarvi, non perderebbero l’occasione di gridare al «Secondo Olocausto» e, di nuovo e ancora più forte, accuserebbero tutto il mondo di questa nuova prova imposta al popolo ebraico, che bisognerebbe allora «risarcire».
Infine, la religione ebraica – lo si vede anche troppo bene con i racconti dell’«Olocausto» – si ancora in ciò che vi è forse di più profondo nell’uomo: la paura. È qui la sua forza. Qui sta la sua possibilità di sopravvivenza malgrado tutti i rischi e malgrado tutti i colpi di maglio sferrati contro i suoi miti dal revisionismo storico. Giocando con la paura, i professionisti del giudaismo vincono ad ogni colpo.
Io sottoscrivo la constatazione del sociologo e storico Serge Thion[60] per il quale «il revisionismo storico, che ha vinto tutte le battaglie intellettuali da venticinque anni a questa parte, perde ogni giorno la guerra ideologica. Il revisionismo si scontra con l’irrazionale, con un pensiero quasi religioso, con il rifiuto di prendere in considerazione ciò che proviene da un polo non ebraico; noi ci troviamo in presenza di una sorta di teologia laica di cui Elie Wiesel è il sommo sacerdote internazionale consacrato dall’attribuzione di un premio Nobel».
IL FUTURO TRA REPRESSIONE E INTERNET
I nuovi venuti del revisionismo non dovranno cullarsi nelle illusioni. Il loro compito sarà arduo. Lo sarà forse meno che per Paul Rassinier e i suoi successori più diretti? La repressione sarà forse meno feroce?
Personalmente, ne dubito. Tuttavia, nel mondo, il cambiamento degli equilibri politici e delle tecniche della comunicazione darà forse alle minoranze la possibilità di farsi sentire meglio che in un recente passato. Grazie a Internet, per i revisionisti sarà forse più facile eludere la censura e le fonti d’informazione storiche diventeranno probabilmente più accessibili.
Resta il fatto che in questa fine secolo e fine millennio l’uomo è chiamato a vivere la strana esperienza di un mondo in cui libri, giornali, radio e catene televisive sono, più che mai, strettamente controllate dal potere del denaro o dalla polizia del pensiero, mentre, parallelamente, si sviluppano, a velocità crescente, nuovi mezzi di comunicazione che sfuggono, in parte, ad ogni controllo. Sembrerebbe un mondo a due facce: una s’irrigidisce ed invecchia, l’altra ha l’insolenza della giovinezza e guarda verso il futuro. Si osserva lo stesso contrasto nella ricerca storica, per lo meno quella che la polizia del pensiero sorveglia: da un lato, gli storici ufficiali, che moltiplicano le opere sull’«Olocausto» o la Shoah, si rinchiudono nel campo delle credenze religiose o del ragionamento cavilloso in completo isolamento, mentre, dall’altro, degli spiriti indipendenti si sforzano di non osservare che i precetti della ragione e della scienza; grazie a questi ultimi, la libera ricerca storica manifesta, in particolare su Internet, una vitalità impressionante.
I sostenitori di una storia ufficiale protetta e garantita dalla legge saranno, per sempre, condannati a trovarsi davanti i contestatori di una verità d’ufficio. Gli uni hanno, con l’età, il potere e il denaro; gli altri, un vero e proprio futuro.
UNA REPRESSIONE CHE S’AGGRAVA
Se c’è un punto su cui la presente opera può apportare tanta informazione ai revisionisti quanta agli antirevisionisti, è quello della repressione che subiscono i primi a causa dei secondi.
Ogni revisionista sa a proprie spese che cosa gli costa esprimersi su un argomento tabù, ma non ha sempre coscienza di ciò che subiscono nello stesso momento i suoi simili in altri paesi oltre al suo. Gli antirevisionisti, dal canto loro, minimizzano sistematicamente l’ampiezza delle loro azioni repressive; essi non pensano che ai propri tormenti, paragonabili a quelli di Torquemada e dei Grandi Inquisitori: essi devono colpire, colpire sempre; il braccio si stanca, hanno i crampi, soffrono, gemono; trovano che, se ci sono degli uomini da compiangere, quelli sono i boia; si coprono gli occhi e si tappano gli orecchi per evitare di vedere e di sentire tutte le loro vittime. A volte addirittura, si stupiscono, forse in buona fede, quando si presenta loro l’elenco dei revisionisti che essi sono riusciti a stroncare nella vita personale, familiare o professionale, a rovinare, a subissare d’ammende o pene carcerarie, a ferire gravemente, a vetrioleggiare, ad uccidere, a spingere al suicidio, mentre all’inverso non si riesce a presentare un solo caso in cui un revisionista abbia torto anche solo un capello ad uno dei suoi avversari.
Bisogna dire che la stampa si adopera per dissimulare il più possibile certi effetti di questa repressione generalizzata. In Francia, il giornale Le Monde a questo proposito ha fatto una sua specialità, come si vedrà, di passare sotto silenzio certi abomini che, se ne fossero stati vittime degli ebrei alla Vidal-Naquet, avrebbero suscitato, su tutta la superficie del globo, cortei di protesta e manifestazioni d’ogni genere.
Il meglio che si possa attendere dagli apostoli della Shoah sarà, tutt’al più, una messa in guardia contro eccessi d’antirevisionismo che potrebbero arrecare danno alla buona fama degli ebrei e alla sacra causa della Shoah.
Nella valanga di tutte le ultime misure di repressione adottate contro i revisionisti, si noterà, per la Francia, la revoca da parte della pubblica Istruzione di Michel Adam, che insegnava storia e geografia in un liceo in Bretagna; a cinquantasette anni, con cinque figli a carico, si ritrova senza la minima risorsa e addirittura, per il momento, senza il reddito minimo d’inserimento (RMI). Quanto a Vincent Reynouard, anche lui revocato dalla pubblica Istruzione, gli è stata appena inflitta una condanna definitiva dal tribunale di Saint-Nazaire, lo scorso 10 novembre, a tre mesi di prigione e a diecimila franchi d’ammenda per aver diffuso l’edizione francese del Rudolf Gutachten (“Rapporto Rudolf”, analisi chimico-fisica delle «camere a gas» di Auschwitz — N.d.T.); ventinove anni, sposato, padre di tre bambini in tenera età, egli si ritrova, assieme alla moglie, senza la minima risorsa. Sempre in Francia, il pastore Roger Parmentier viene escluso dal partito socialista per aver dato il suo sostegno dinanzi ad un tribunale a Roger Garaudy, mentre Jean-Marie Le Pen, da parte sua, è sottoposto ad indagine, in Francia come pure in Germania, per una dichiarazione anodina sul «dettaglio» delle camere a gas.
A Barcellona, il 16 novembre, su istanza del Centro Simon Wiesenthal, di SOS-Razzismo-Spagna, delle due comunità israelitiche della città e del Movimento ebraico liberale spagnolo, il libraio Pedro Varela ha ricevuto una condanna definitiva a cinque anni di carcere per «negazione dell’Olocausto» ed «incitamento all’odio razziale» con gli scritti. Egli è anche condannato ad un’ammenda di trentamila franchi e a delle gravose spese giudiziarie. I 20.972 libri e le centinaia di cassette che compongono il fondo della sua libreria saranno distrutti… dalle fiamme. La sua libreria era stata fatta segno d’attentati e d’incendi. A più riprese, erano stati aggrediti il suo dipendente o lui stesso. Il Centro Simon Wiesenthal tenterebbe oggi di ottenere l’annullamento del dottorato di storia concesso a Pedro Varela più di dieci anni fa[61].
In Germania, si sequestrano e si bruciano sempre più spesso scritti revisionisti. Gary Lauck (cittadino americano estradato dalla Danimarca in Germania), Günter Deckert e Udo Walendy vegetano sempre in carcere e possono ritenersi fortunati se non si prolunga la loro incarcerazione con il minimo pretesto. Erhard Kemper, di Münster, dopo un anno di prigione e sotto la minaccia di nuove e pesanti pene che lo terrebbero in carcere probabilmente fino alla fine della sua vita, ha dovuto rifugiarsi nella clandestinità. Altri Tedeschi o Austriaci vivono in esilio.
In Canada, continua il calvario di Ernst Zündel e dei suoi amici dinanzi ad uno di questi tribunali ad hoc, detti «commissioni dei diritti umani», dove ci si fa, allegramente, beffe dei normali diritti di difesa; per esempio, uno ha il divieto di sostenere che ciò che ha scritto corrisponde ad una verità verificabile; queste commissioni non si preoccupano della verità; a loro interessa solo sapere se ciò che è scritto arreca o no dispiacere ad alcuni! Altre commissioni speciali collegate con l’Intelligence Service del Canada, prendono le decisioni, nel caso dei revisionisti, a porte chiuse in base ad un fascicolo non comunicato all’interessato. Nel 1999, Ottawa adotterà una legge antirevisionista che autorizza la polizia a sequestrare a domicilio qualsiasi libro o materiale che potrebbe, secondo la polizia stessa, propagare il revisionismo; questa stessa legge stipulerà che i tribunali allineeranno la loro prassi a quella delle commissioni ad hoc e non permetteranno più all’accusato di difendersi invocando la verità di ciò che egli ha scritto[62].
Dappertutto nel mondo le associazioni ebraiche moltiplicano le iniziative per l’adozione di una legge antirevisionista specifica. Recentemente, in occasione di una conferenza riunita a Salonicco, l’Associazione internazionale degli avvocati e giuristi ebrei ha reclamato l’instaurazione in Grecia di una tale legge ed ha fatto sapere che terrà delle conferenze identiche in altri venti e più paesi[63].
IL DOVERE DI RESISTERE
Quali che possano essere le tempeste e le vicissitudini presenti o a venire, lo storico revisionista deve mantenere la rotta. Al culto di una memoria tribale fondata sulla paura, la vendetta e il lucro, egli preferirà la ricerca ostinata dell’esattezza. In questo modo, anche senza volerlo, egli renderà giustizia alle vere sofferenze di tutte le vittime della seconda guerra mondiale. E, da questo punto di vista, sarà lui ad evitare qualsiasi discriminazione di razza, di religione, di comunità. Soprattutto, rifiuterà l’impostura suprema che ha coronato questo conflitto: quella del processo di Norimberga, del processo di Tokyo e di altri mille processi del dopoguerra in occasione dei quali, ancora oggi, il vincitore, senza dover rendere il minimo conto dei propri crimini, si arroga il diritto di perseguire e condannare il vinto.
Contrariamente alla visione romantica di Chateaubriand, lo storico non è affatto «incaricato della vendetta dei popoli» e, ancor meno, della vendetta di un popolo che si pretende eletto da Dio.
Su qualunque argomento, lo storico in generale e lo storico revisionista in particolare non hanno altra missione che di verificare se ciò che si dice è esatto. Si tratta qui di una missione elementare, ovvia, ma – l’esperienza insegna – pericolosa.
3 dicembre 1998
_________________
Note
1 Queste parole sono di Karl Schlögel, nell’assumere la difesa di Gabor Tamas Rittersporn accusato da Maxime Leo (“Holocaust-Leugner im Berliner Centre Marc Bloch”, Berliner Zeitung, 12 febbraio 1998) di aver dato il suo sostegno alla libertà d’espressione di Robert Faurisson nel 1980 (“Eine Jagdpartie. Wie man einen Wissenschaftler ruiniert”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18 febbraio 1998, p. 42).
2 «Nel luglio 198[6], la Knesset votò una legge che vietava la negazione del Genocidio: “La diffusione, scritta o orale, di opere che negano gli atti commessi durante il periodo del regime nazista – crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l’umanità – nonché i discorsi che minimizzano l’importanza di questi atti allo scopo di difendere coloro che li hanno perpetrati, e il sostegno o l’identificazione con i colpevoli sono passibili di pena detentiva di cinque anni”. Fu respinta una proposta di elevare la pena a dieci anni di detenzione. Così lo sterminio degli Ebrei non costituiva più un argomento di ricerca storica; quest’evento era stato, in qualche modo, stralciato dalla Storia stessa, ed era diventato un dogma nazionale, protetto dalla legge, che godeva di uno stato giuridico simile a quello del credo religioso, persino più elevato: la massima pena quanto a “grossolanità” nei confronti della sensibilità o della tradizione religiosa – compresa probabilmente la negazione dell’esistenza di Dio – è di un anno di carcere» (Tom Segev, Le Septième Million. Les Israéliens et le Génocide, Liana Levi, 1993 [uscito nel 1991 in Israele], p. 535).
3 Bulletin quotidien d’informations de l’Agence télégraphique juive, 2 giugno 1986, p. 1, 3.
4 Ved. Robert Maxwell , “J’accuse” [in francese nel testo], Sunday Mirror, 17 luglio 1988, p. 2.
5 I «bambini ebrei [erano] gettati vivi nei crematori» (Pierre Weill, direttore della SOFRES [omologo francese del CENSIS — N.d.T.], “L’anniversaire impossible”, Le Nouvel Observateur, 9 febbraio 1995, p. 53).
6 «È d’altronde interessante […] sottolineare che il ghetto è storicamente un’invenzione ebraica» (Nahum Goldmann, Le Paradoxe juif, Stock, Parigi 1976, p. 83-84); ved. anche Pierre-André Taguieff, “L’identité juive et ses fantasmes”, L’Express, 20-26 gennaio 1989, p. 65.
7 Eric Conan, Auschwitz: la mémoire du mal, L’Express, 19-25 gennaio 1995, p. 68.
8 Ibid. Nel 1992, cioè molto tempo dopo la «fine degli anni ’70», un giovane revisionista californiano d’origine ebraica, David Cole, si presenterà come scopritore delle falsificazioni della «camera a gas» di Auschwitz-I. In un video mediocre, egli mostrerà, da una parte, la versione delle guide del museo (questa camera a gas è autentica) e, dall’altra, la versione di un responsabile del museo, Franciszek Piper (questa camera a gas è «very similar» [molto simile] all’originale). Fino a qui niente di nuovo. Il guaio è che D. Cole ed i suoi amici hanno poi di gran lunga esagerato – per non dire di più – quando sono arrivati a pretendere che F. Piper aveva riconosciuto che c’era stata «frode». Effettivamente, c’era stata frode, ma purtroppo D. Cole non aveva saputo dimostrarlo perché mal conosceva il dossier revisionista. Egli avrebbe potuto confondere definitivamente F. Piper mostrandogli, con la videocamera, le mappe originali, che io avevo scoperto nel 1975/1976 e pubblicato «alla fine degli anni ’70». Si vede molto bene che l’attuale pretesa «camera a gas» è la risultante di un certo numero di truccature del luogo alle quali si è proceduto dopo la guerra. Per esempio, i quattro pretesi «orifizi di scarico dello Zyklon B» praticati nel soffitto sono stati praticati – in modo molto grossolano e maldestro – dopo la guerra: i ferri per il cemento sono stati spezzati dai comunisti polacchi e lasciati così come stavano.
9 R. J. van Pelt e D. Dwork, Auschwitz: 1270 to the Present, Yale University Press, Londra 1996, p. 363-364, 367, 369.
10 J.-C. Pressac, “Enquête sur les chambres à gaz, Auschwitz, la Solution finale”, collezioni du mensile L’Histoire, n. 3, Parigi, ottobre 1998, p. 41.
11 Jacques Baynac su Le Nouveau Quotidien (di Losanna), 2 settembre 1996, p. 16, e 3 settembre 1996, p. 14; ved. prima di quella data J. Baynac e Nadine Fresco, “Comment s’en débarrasser?”, Le Monde, 18 giugno 1987, p. 2.
12 A volte si è sostenuto che la cifra di sei milioni trovava origine in un articolo di giornale del… 1919: Martin H. Glynn (ex governatore dello Stato di New York), “The Crucifixion of Jews Must Stop!”, The American Hebrew, 31 ottobre 1919, p. 582. Detto M. H. Glynn lanciava una richiesta di fondi in favore di sei milioni di ebrei europei che, diceva, erano affamati e perseguitati e vivevano così un «olocausto», una «crocifissione». La parola «olocausto» nella sua accezione di «disastro» è attestata in inglese nel XVII secolo; qui, nel 1919, designava le conseguenze di una carestia descritta come un minaccioso disastro. Nel 1894, Bernard Lazare applicava la parola ai massacri degli ebrei: «… di tanto in tanto, re, nobili o borghesi offrivano ai loro schiavi un olocausto di ebrei […] si offrivano degli ebrei in olocausto» (L’Antisémitisme, son histoire et ses causes, L. Chailley, Parigi 1894, ried. La Vieille Taupe, Parigi 1985, p. 67, 71).
13 «Till now six times a million Jews from Europe and Russia have been destroyed», Lucy S. Dawidowicz, in una compilazione, A Holocaust Reader, Behrman House, New York 1976, p. 327; si tratta di lettere tradotte dall’ebraico e pubblicate a New York nel 1960 con il titolo Min hametzar.
14 Io sono debitore di questa scoperta allo storico tedesco Joachim Hoffmann; in Stalins Vernichtungskrieg 1941-1945, Verlag für Wehrwissenschaften, 2a edizione, Monaco 1995, p. 161 e n. 42 da p. 169, egli segnala che Ilya Ehrenburg dà questa cifra in un articolo di Soviet War News del 4 gennaio 1945 intitolato: “Once Again Remember!”. Cercando di verificare questo punto all’Imperial War Museum di Londra, non ho trovato niente con quella data; in compenso, ho trovato il testo segnalato da J. Hoffmann con un altro titolo e con un’altra data: con il titolo “Remember, Remember, Remember” e in data 22 dicembre 1944, p. 4-5. Bisognerebbe forse dedurne che Soviet War News era pubblicato sotto diverse forme?
15 Ved. “Number of Living Holocaust Survivors”, Adina Mishkoff, assistente amministrativa presso l’AMCHA (National Israeli Center for Psychosocial Support of Survivors of the Holocaust and the Second Generation), Gerusalemme, 13 agosto 1997 (cifre fornite dal gabinetto del primo ministro israeliano).
16 Il misero e fallace plastico (con le sue pretese aperture per lo Zyklon nel tetto mentre tali aperture, lo si constata ancora oggi, non sono mai esistite, e con le sue pretese colonne forate mentre le colonne di cemento, come si può ancora vedere, erano piene) è riprodotto su un altro libro-guida pubblicato nel 1995; ved. Jeshajahu Weinberg e Rina Elieli, Rizzoli, New York, p. 126-127; in compenso, questo libro-guida non riproduce ciò che, nel precedente libro-guida, quello di M. Berenbaum, era presentato come il corpo del reato per eccellenza delle gassazioni omicide: una pretesa porta di camera a gas a Majdanek.
17 Le Nouvel Observateur, 30 settembre 1993, p. 96.
18 Tous les fleuves vont à la mer (Mémoires 1), Le Seuil, Parigi 1994, p. 97.
19 The Holocaust and History. The Known, the Unknown, the Disputed and the Reexamined, opera realizzata sotto la direzione di Michael Berenbaum e Abraham J. Peck in associazione con l’United States Holocaust Memorial Museum (Washington), Indiana University Press, Bloomington e Indianapolis (Indiana, Stati Uniti) 1998, xv-836 p., 55 contributi.
20 Ivi, p. 15.
21 Ved. n. 16 sopra.
22 A proposito di Timisoara, ved. Écrits révisionnistes, vol. III, p. 1141-1150, il mio studio del libro di Michel Castex, Un Mensonge gros comme le siècle. Roumanie, histoire d’une manipulation, Albin Michel, Parigi 1990.
23 Il preteso plastico di crematorio con «camera a gas» che si presenta al Museo nazionale di Auschwitz e quello che si può vedere all’Holocaust Memorial Museum di Washington sono talmente succinti per quanto concerne proprio la «camera a gas» e talmente in contraddizione con le vestigia che si possono esaminare sul posto, ad Auschwitz-Birkenau, che è ridicolmente facile provare che questi due plastici sono pure fantasie; ved. nota 16 sopra.
24 Ved. Weltwoche (Zurigo), 27 agosto e 3 settembre 1998; Nicolas Weill, “La mémoire suspectée de Binjamin Wilkomirski”, Le Monde, 23 ottobre 1998, p. V.
25 Donald Watt, Stoker: the story of an Australian soldier who survived Auschwitz-Birkenau, Simon & Schuster, New York 1995.
26 Fred Sedel, Habiter les ténèbres, La Palatine, Parigi-Ginevra 1963, e A.-M. Métaillié, Parigi 1990.
27 Vivre c’est vaincre (Hérault-Editions, Maulévrier 1988) è presentato come se fosse stato scritto nel 1945 e stampato nel 3° trimestre del 1946. Nel 1988, avviene una riedizione da parte di Hérault-Editions con gran chiasso. La fascetta pubblicitaria reca scritto: «Sono stato testimone dell’Olocausto». È su Le Figaro del 15 maggio 1996 (p. 2) che il generale Rogerie dichiarerà di aver «assistito alla Shoah a Birkenau». La descrizione, estremamente succinta, che gli è fatta delle «camere a gas» e dei forni è contraria alla versione oggi ammessa: il suo «testimone» ha parlato di gas che arrivava dalle cipolle delle docce e di forni elettrici (p. 75).
28 A. Rogerie, Vivre c’est vaincre, p. 70, 85.
29 Ivi, p. 82.
30 Ivi, p. 83
31 Ivi, p. 84
32 Ibidem.
33 Ivi, p. 87.
34 Samuel Gringauz, “Some Methodological Problems in the Study of the Ghetto”, Jewish Social Studies / A Quarterly Journal Devoted to Contemporary and Historical Aspects of Jewish Life, vol. XII, New York 1950, p. 65.
35 Op. cit., p. 148-149.
36 They Have Their Exits, Hodder and Stoughton, Londra 1953, p. 172.
37 Di un testo di più di duecentocinquanta parole si ricorderà in particolare: «Più di dodici milioni di morti! Altrettanti individui che non sono nati! Ancora più mutilati, feriti, vedove e orfani! Per innumerevoli miliardi di distruzioni varie. Fortune scandalose edificate su miserie umane. Innocenti alla forca. Colpevoli agli onori. La vita atroce per i diseredati. Il formidabile conto da pagare». Altrove si legge: «Bisogna migliorare lo spirito delle Nazioni migliorando quello degli individui con un’istruzione più sana e largamente diffusa. Bisogna che il popolo sappia leggere. E soprattutto capire il valore di ciò che legge». Il testo termina con: «Sia maledetta la guerra. Ed i suoi artefici!»
38 Ved. Christiane Gallus, “Une pandémie qui a fait trois fois plus de victimes que la guerre de 1914-1918”, Le Monde, 31 dicembre 1997, p. 17.
39 Pierre Kaufmann, “Le danger allemand”, Le Monde, 8 febbraio 1947.
40 Ved. Mark Weber, Bergen-Belsen Camp: The Suppressed Story, Journal of Historical Review, maggio-giugno 1995, p. 23-30.
41 Tale fu il caso, per esempio, di Bartley C. Crum, Behind the Silken Curtain, Simon & Schuster, New York 1947, p. 114.
42 Arthur Suzman e Denis Diamond, Six Million Did Die: the truth shall prevail, pubblicato dal South African Jewish Board of Deputies, Johannesburg 1978, 2a edizione, p. 18.
43 Nel 1945, A. Hitchcock, nato nel 1899, era già noto. Per i suoi gusti macabri o morbosi, per la sua arte nel «manipolare il pubblico», per lo strano fascino che il gas esercitava sulla sua mente, si leggerà Bruno Villien, Hitchcock, Colonna, Parigi 1982, p. 9-10.
44 Le Figaro, 24 ottobre 1997, p. 10.
45 The Origins of Totalitarianism, Harcourt, Brace, New York 1951, p. 446, n. 138.
46 Le Figaro, 16 gennaio 1995, p. 29.
47 Libération, 18 dicembre 1995, p. 41.
48 Pierre Vidal-Naquet, “Le secret partagé”, Le Nouvel Observateur, 21 settembre 1984, p. 80.
49 Lettera a Nation Review (Australia), 21 giugno 1979, p. 639.
50 “The Left, the Right and the Jews”, seconda parte, Quadrant (Australia), settembre 1979, p. 27.
51 Avv. Bernard Jouanneau, La Croix, 23 settembre 1987, p. 2.
52 The Globe and Mail (Toronto, Canada), 2 giugno 1998, pag. A1, 15. Edgar Bronfman, presidente del Congresso mondiale ebraico, è il re dell’alcool e della pornografia. Egli presiede il gruppo Seagram e, a Hollywood, possiede la Universal Studios. Ha appena ricevuto, da una giuria di uomini politici americani, l’onorificenza Silver Sewer (Cloaca d’argento), in particolare per i reality show dell’ebreo Jerry Springer, trasmissioni che mettono in scena spogliarelliste incinte, giovani prostitute che si picchiano con i loro protettori, beccamorti che copulano con i cadaveri, ecc. (Financial Times, 21-22 marzo 1998, p. 2).
53 B. Lazare, L’Antisémitisme…, prima pagina del primo capitolo.
54 Ivi, p. 27.
55 A. Kaspi, Les Juifs pendant l’Occupation, ed. riveduta ed aggiornata, Le Seuil, Parigi 1997 [1991], p. 109, n. 27
56 Io sento a volte dire che rischia di costare più caro ad un ebreo che ad un non ebreo fare professione di revisionismo. I fatti smentiscono quest’asserzione. Non un ebreo è stato condannato in tribunale per revisionismo, nemmeno Roger-Guy Dommergue (Polacco de Menasce) che, da anni, moltiplica i più veementi scritti contro ciò che egli chiama le menzogne dei suoi «congeneri». Fino ad ora non si è osato applicargli né la legge Pleven (1972) né la legge Fabius-Gayssot (1990). È opportuno tuttavia ricordare il caso del giovane revisionista americano David Cole che mostra a quale violenza possono ricorrere certe organizzazioni ebraiche per far tacere degli ebrei che hanno preso partito per la causa revisionista.
57 Un ricercatore indipendente, pure se non si proclama tale, può indirettamente contribuire al revisionismo con la semplice qualità del suo lavoro. Farò qui un nome, quello di Jean Plantin, responsabile di una pubblicazione il cui titolo, da solo, indica il carattere erudito: Akribeia – tale è il titolo di questa pubblicazione semestrale – significa «esattezza», «cura minuziosa» e ha dato in francese la parola acribie (qualità dell’erudito che lavora con un’estrema cura): Éditions Akribeia, 45/3, Route de Vourles, 69230 Saint-Genis-Laval, Francia.
58 Ved. la pertinente analisi di Guillermo Coletti “The Taming of Holocaust Revisionism” [L’addomesticamento del revisionismo dell’Olocausto], 13 novembre 1998, Anti-Censorship News Agency.
59 «L’oubli n’est pas notre principale vertu» (il presidente del Concistoro di Tolosa, secondo Le Figaro, 9 ottobre 1997, p. 10).
60 S. Thion è, in particolare, autore di un’opera revisionista che reca il titolo eloquente di Une Allumette sur la banquise. Un’opera revisionista, anche se il suo contenuto sembra essere dinamite, non apporta forse, in fin dei conti, maggiore chiarezza e calore di un fiammifero «nella notte polare, sulla banchisa delle idee congelate» (p. 90).
61 Ved. “Un libraire espagnol condamné pour ‘apologie du génocide’”, Le Monde, 19 novembre 1998, p. 3; Emmanuel Ratier, Faits & Documents, 1° dicembre 1998, p. 12.
62 Ved. “Crackdown on hate materials planned”, National Post (Canada), 25 novembre 1998.
63 Athens News, 28 giugno 1998, p. 1
