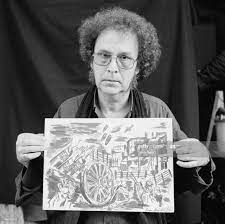L’impostura Wilkomirski resterà impunita
Destinato a conoscere un successo mondiale ed a raccogliere un enorme plauso prima di cadere, qualche anno più tardi, nel discredito generale, un libricino dal titolo Bruchstuecke aus einer Kindheit 1939-1948 (Frammenti da un’infanzia 1939-1948) veniva pubblicato alla fine del 1995, sotto il nome di Binjamin Wilkomirski, dallo Juedischer Verlag di Francoforte, casa editrice del prestigioso editore Suhrkampf. In seguito l’opera verrà tradotta in una dozzina di lingue. La traduzione francese, dovuta a Léa Marcou, apparve nel gennaio 1997 presso le edizioni Calmann-Levy con il titolo Fragments / Une enfance 1939-1948; quella italiana già nel 1996 presso Mondadori, Milano con il titolo Frantumi: un’infanzia, 1939-1948. [Nel presente articolo i riferimenti portano all’edizione francese – NdT]
In quarta di copertina dell’edizione francese si poteva leggere:
Binjamin Wilkomirski non conosce la sua data di nascita, ignora le sue origini precise e non ha più alcun parente. – È ancora giovane quando le retate di ebrei si intensificano in Polonia. Suo padre viene assassinato sotto i suoi occhi, viene strappato alla sua famiglia e deportato, a quattro anni, al campo di sterminio di Majdanek. “I miei primi ricordi assomigliano a un campo di rovine, disseminati di immagini e di avvenimenti isolati. Dei frammenti di memoria dai contorni duri, taglienti, che ancora oggi non posso toccare senza ferirmi. Spesso in un disordine caotico e, per lo più, impossibile da classificare in ordine cronologico. Dei frammenti che resistono ostinatamente alla voglia d’ordine dell’adulto che sono diventato e sfuggono alle leggi della logica”. Sono questi frammenti che l’autore ci restituisce attraverso lo sguardo del bambino che fu. – Un libro indimenticabile, capolavoro di scrittura e d’emozione. – Binjamin Wilkomirski vive oggi in Svizzera. Fabbrica strumenti musicali ed è clarinettista.
Un prodotto di bassa fabbricazione
In realtà, questo opuscolo di 150 paginette è un capolavoro di non scrittura e di assenza di emozioni. Si tratta di un prodotto di bassa fabbricazione nel quale l’autore si prende gioco di noi. Ben lungi dallo scoprirvi “frammenti di memoria dai contorni duri, taglienti”, il lettore non incontrerà altro che del flaccido, dell’inconsistente, dell’indefinito (nel tempo e nello spazio), del confuso, del vago, del fumoso; vapore, nebbia, del grigio. L’azione ristagna. I dialoghi suonano vuoti. Il tono è falso: le grida che l’eroe lancia continuamente, nonché le sue paure e le sue collere accadono per lo più senza rima né ragione.
Se tutto è nel vago, lo è di proposito. Manifestamente l’autore ha evitato di fornire precisazioni sui luoghi, sui tempi o sui personaggi, perché temeva di contraddirsi. Egli pretende di essere stato internato a Majdanek ma si guarda bene dal descrivere il campo, tranne nel dotarlo d’una collina, che, nella realtà, non è mai esistita. In seguito dà ad intendere di essersi trovato ad Auschwitz, ma non scrive il nome di Auschwitz, di modo che non si potrà rimproverargli di aver commesso un tale errore riguardo a questo campo. A parte rare eccezioni, i personaggi non hanno veramente delle uniformi, dei gradi, delle lingue, degli impieghi precisi e nemmeno, e ciò è il colmo, dei tratti davvero distintivi; non sono che fantasmi od orchi di cartapesta. I paesaggi percorsi sono ovunque e da nessuna parte. Questa attenzione a cancellare ogni dettaglio compromettente è caratteristica del mentitore o del falsario. Essa esclude la buona fede. Pretendere che l’autore abbia finito col credere al suo proprio racconto sarebbe un errore. Il nostro imbroglione è costantemente sul chi vive. Si sorveglia come fanno i bugiardi. Non divaga. Non cede all’illusione. Fabbrica, forgia il suo racconto pezzo per pezzo e frase per frase, laboriosamente.
A titolo d’esempio, ascoltiamolo evocare “l’Uniforme” (per parlare di un guardiano), “la Grande Baracca”, “le donne-uniformi grigie di Polonia”, “il Nuovo”, “la silhouette” (egli nutre un affetto particolare per questa parola), “delle forme grigie”, “una Blockowa”, “un’ausiliaria SS in grigio”, “un’uniforme nera”, “i contorni neri delle uniformi”, “un bruno-verde”. E poi ecco ancora “una Uniforme” (parlando di una guardiana, pag. 68), “lo stivalato” (pag. 73), esseri grigi, a brandelli, adulti senza forma definita (pag. 82). Ad un certo momento, l’autore dice di aver fatto parte di un trasporto ma, circa il mezzo di locomozione, scrive: “Non so nemmeno se si trattasse di un camion o di un vagone ferroviario” (pag. 86); così facendo, egli si tutela da ogni rischio di mettere una linea ferroviaria là dove in realtà, durante la guerra, non ne erano forse esistite. Nella stessa pagina aggiunge: “Solo la fine del viaggio mi è rimasta nella memoria, e anch’essa in modo lacunoso, confuso, in frammenti di immagini difficili da ricollocare; troppi pezzi mancano al puzzle”. Notiamo, di passaggio, quanto qui sia pungente ascoltare il falsario all’opera parlarci di “pezzi” di un “puzzle”. Egli è d’accordo per confidarci: “Tutto era confuso, vago” (pag. 95), il che è il meno che si possa dire. Intravede delle “donne che emergevano talvolta dalla semi-oscurità come delle ombre” (pag. 103). Scrive inoltre: “Era una ragazza o un ragazzo?” E per una volta si appresta a darci un cognome ma non ne farà nulla; non avremo diritto che a un nome, e ancora: “Lo si chiamava Kobo, Kola o Kala, non lo so più molto bene” (pag. 103). Per l’autore “qui tutto annega in una nebulosa penombra” (pag. 111), mentre che là non c’erano più che delle “immagini brumose” (pag. 109); in realtà, non è solo “qui” o “là” ma ovunque nel racconto che non si incontra che della nebbia, della penombra o della bruma.
Sempre a titolo d’esempio, preleviamo un capoverso in mezzo ad altri cento, che ci offrirà un assaggio di questa letteratura all’olio di gomito:
La città, la gente, gli altri bambini mi spaventavano. Delle domande sempre più strazianti si aggrovigliavano nel mio cervello, lo corrodevano come l’acido. A volte, esse mi sommergevano lo spirito, come una colata di piombo fuso. Ero incapace di esprimerle, mi incollavano la gola e la bocca, mentre il mio cuore batteva all’impazzata minacciando poi di arrestarsi. Ma non una parola usciva dalla mia bocca, il che mi privava d’ogni speranza di risposta (pag. 112).
150 pagine di questo sproloquio tradotto dal tedesco avrebbero dovuto dare la sveglia ai più creduli. Tutti avrebbero dovuto rendersi conto che B. Wilkomirski appartiene alla categoria dei falsi testimoni i quali, non avendo nulla da riportare rispetto ad un’esperienza vissuta, si sono ridotti a creare un puzzle con dei clichés da bazar, degli stereotipi, del kitsch e del sentimentalismo prefabbricato.
Grand-guignolesco
Altrettanto fittizio è il racconto delle atrocità con cui l’autore mette il pepe al suo preteso racconto autobiografico. Nel suo libro i cattivi trascorrono la maggior parte del loro tempo ad afferrare sornionamente dei bambini per lanciarli da una finestra, contro un muro, per fracassare loro il cranio, per bucare loro la fronte con una pallottola, per seppellirli vivi nel fango, per gettarli nel fuoco, per farne del combustibile (sic), o, più semplicemente, a sollevarli dal suolo prendendoli per le orecchie, a rinchiuderli in cucce verminose, a farli marciare negli escrementi fino alle ginocchia, a piantare dei bastoncini di vetro “nei peni dei bambini” (pag. 60). In un ammasso di cadaveri, si vede la pancia di una donna gonfiarsi e poi aprirsi; il nostro uomo ne dà conferma:
L’addome si strappa e un enorme ratto, tutto brillante, imbrattato di sangue, scende dal mucchio di cadaveri. Altri ratti spaventati spuntano dal groviglio di corpi e prendono il largo. Io l’ho visto! L’ho visto! Le donne morte partoriscono dei ratti! I ratti! Il nemico mortale dei bambini del campo. I ratti ci attaccano notte dopo notte, i loro morsi ci infliggono delle ferite terribilmente dolorose, inguaribili, delle ferite che nulla può cicatrizzare e che fanno imputridire vivi i bambini! (pag. 84).
Dopo la guerra, diventato, nell’opulenta Svizzera, l’ospite di una pensione per bambini, pare abbia conservato tutte le sue paure. Per convincerci di ciò egli cita tre esempi di ossessioni che gli impediscono, sembra, di percepire la semplice ed inoffensiva realtà. Egli evoca successivamente dapprima un’immagine di Gugliemo Tell, poi lo spettacolo di bambini che si esercitano al tiro in un baraccone da fiera e, infine, la vista di un paio di giovani sciatori trascinati dall’asta di una risalita meccanica. Ora non è proprio in Guglielmo Tell che egli crede di vedere un SS che prende di mira un bambino per ucciderlo al fine di derubarlo e mangiargli la sua mela (pag. 128)? Agli esercizi di tiro egli immagina che dei bambini-soldati tentino di uccidere la padrona del baraccone, bersaglio che fortunatamente essi mancano (pag. 133). Quanto all’impianto di risalita, senza nient’altra prova che non sia il rumore, quello non può essere che “la macchina della morte”, mentre il direttore della pensione per bambini è, a colpo sicuro, “il boia” che, assistito da un aiutante, fissa i pargoli due a due ad un cavo in modo che vengano sollevati e spariscano oltre la cima della montagna in un “gigantesco buco nero” (pag. 138-139). Di per sé, queste elaborate sciocchezze avrebbero dovuto spingere qualsiasi editore a rifiutare il manoscritto. Ma, nella letteratura olocaustica, queste invenzioni costituiscono la legge del genere, ed è precisamente alla vista di simili asinerie che un editore, abituato ai racconti della mitologia concentrazionaria, si dirà: “Così va bene, ora ci siamo. Questa testimonianza è nella norma. Porta il sigillo d’autenticità dell’olocausto.” Tanto è vero che, abituati ad un cibo adulterato, non si vuole più altro.
Un best-seller ebraico
A dispetto della sua atroce qualità letteraria e delle sue invenzioni degne del Grand-Guignol, il libro è riuscito a diventare in breve tempo un best-seller.
Alla sua apparizione, il gotha della Shoah cade in estasi. Soffoca di ammirazione davanti alla forza della testimonianza ed al talento dell’autore. Léa Balint, specialista israeliana dei bambini della Shoah, Lawrence Langer, Daniel Jonah Goldhagen, Blake Eskin se ne fanno i paladini, con Wolfgang Benz, direttore, a Berlino, del Centro di Ricerca sull’Antisemitismo e, in Francia, con Annette Wieviorka. Dal New York Times al Nouvel Observateur, dal Daily Telegraph e dal Guardian a Le Monde, i media fremono di felicità. Negli Stati Uniti, il libro viene promosso dall’Holocaust Memorial Museum di Washington ed incoronato dal National Jewish Book Award for Autobiography (Premio Nazionale del Libro Ebraico per l’Autobiografia), mentre l’associazione delle biblioteche americane lo inserisce, nel 1997, nella lista dei “Best Books for Young Adults”. In Gran Bretagna esso riceve il premio letterario del Jewish Quarterly e, in Francia, il premio “Mémoire de la Shoah”. La testimonianza orale di B. Wilkomirski viene preziosamente raccolta dalla Shoah-Foundation di Steven Spielberg, fondazione destinata a raccogliere in video 50.000 testimonianze in quasi 50 paesi per provare all’universo che i revisionisti sono dei falsari della storia. Binjamin Wilkomirski moltiplica i viaggi e le conferenze, in particolare nelle scuole. Egli ammassa una fortuna. Primo miracolo: ritrova suo padre in Israele; si tratta di un sopravvissuto di Majdanek che porta il nome di Jaacov Morrocco; sotto l’occhio delle telecamere padre e figlio si gettano piangenti l’uno nelle braccia dell’altro. Secondo miracolo: una Californiana che dice di chiamarsi Laura Gabrowski e si presenta come una scampata da Auschwitz pretende di averlo conosciuto in questo campo: la rimpatriata, anche qui, si fa in presenza delle telecamere, all’aeroporto di Los Angeles. Laura Grabowski lo accoglie a braccia aperte e con grandi grida: “He’s my Binji!” Essa esibisce delle cicatrici dovute agli esperimenti medici di Mengele. È una musicista. Il nostro clarinettista e la sua compagna partono per delle tournées di conferenze e concerti. Si recano in pellegrinaggio ad Auschwitz e là, sul posto, sempre davanti alle telecamere, il nostro eroe rivela che Mengele lo aveva sottoposto a degli esperimenti medici per cambiare in azzurro il marrone dei suoi occhi, episodio di cui non aveva fiatato nel suo libro. Sopravviene un incidente che avrebbe dovuto dare la sveglia: quando gli si chiede di descrivere Mengele, Wilkomirski si rifiuta (“Il bambino dei campi della morte: verità o menzogne”, documentario per la televisione britannica di Christopher Oliglati, 1999).
L’impostura svelata
Ben presto, fin dal 1995, un giornalista svizzero, Hanno Helbling, capo del servizio culturale della Neue Zuercher Zeitung, aveva messo in guardia l’editore tedesco Suhrkampf contro la soperchieria. Ma Helbling, non avendo la fortuna d’essere ebreo, era stato congedato come un volgare revisionista. Bisognerà attendere che intervenga nel settimanale svizzero Die Weltwoche (27 agosto e 3 settembre 1998) un ebreo di nome Daniel Ganzfried, nato in Israele e vivente in Svizzera, perché si metta in marcia il processo che sfocerà in una serie di rivelazioni sulla vera identità dell’impostore. Evidentemente tutto il credito della scoperta andrà all’ebreo e non al “revisionista” H. Helbling, il cui nome verrà presto dimenticato.
Si apprende allora che, per quanto attiene al suo vero nome, Binjamin Wilkomirski si chiamava, di fatto, Bruno Grosjean. Figlio naturale, nato il 12 febbraio 1941 nel cantone di Bienne, egli viene affidato da sua madre, Yvonne Berthe Grosjean, ad un orfanotrofio. Adottato da una coppia di zurighesi benestanti, i Doesseker, prende il nome di Bruno Doesseker. Sua madre muore nel 1981 e lui ne riceve la magra eredità. Non è mai stato ebreo. La sua nascita a Riga è una pura invenzione. Ha trascorso tutta la sua infanzia in Svizzera e non a Majdanek, ad Auschwitz o in un qualsiasi altro luogo della Lettonia, della Polonia o della Germania. Non ha mai vissuto in un orfanotrofio di Cracovia. Un’analisi genetica prova che è sprovvisto di un qualsiasi legame di parentela con Jaacov Morrocco. Non ha conosciuto Riga, Auschwitz o Cracovia che come turista e ben dopo la guerra.
Laura Grabowski è ciò che si chiama una “truffatrice in gonnella”. Il suo vero nome è Rose Wilson: nata in America da genitori cristiani ad Auburn (Stato di Washington). Dieci anni prima, sotto lo pseudonimo di Lauren Stratford, aveva firmato un libro in cui si presentava come vittima di rituali satanici, esibendo allora, delle cicatrici: le stesse cicatrici che, più tardi, avrebbe attribuito agli esperimenti di Mengele.
L’impostore inizia a dibattere contro le accuse. Mescola proteste, minacce e gemiti. In mancanza del suo vero padre viene ritrovato il suo vero zio, il quale accetta di prestarsi ad un test genetico, ma l’impostore, lui, si rifiuta. Iniziano a venire alla luce delle testimonianze di persone che l’hanno conosciuto bene: ne emerge che, fin dalla sua gioventù, Bruno aveva una forte propensione alla menzogna. Si apprende che uno psicoterapeuta ebreo, Elitsur Bernstein, ha partecipato all’impresa del falsario. Specialista di ricordi rimossi, aveva aiutato il clarinettista a “ricostituire” la sua identità di Binjamin Wilkomirski, pretesamente nato a Riga, poi messo in orfanotrofio a Cracovia e deportato nei campi di concentramento nazisti. Degli ebrei cominciano a prendere le distanze da questo “goy” che ha giocato a fare l’ebreo e la cui impostura, diventata troppo evidente, rischia di causare del danno alla comunità. Raul Hilberg e Yehuda Bauer esprimono il loro scetticismo. Delle ebree come Judith Shulevitz in Canada o Debórah Dwork e Deborah Lipstadt negli Stati Uniti persistono nel difendere l’impostore o la sua opera; secondo loro, importa dopo tutto assai poco che il racconto sia autentico o meno, e bisogna innanzitutto fare attenzione a non fare il gioco dei revisionisti. Nel 1999, Elena Lappin, ebrea di origine russa, ha consacrato all’affare uno studio, The Man with two Heads (L’Uomo con due teste), che sarà tradotto e pubblicato in francese nel 2000 dalla casa editrice L’Olivier (Presidente e direttore generale: Olivier Cohen) col titolo L’Homme qui avait deux tetes (L’Uomo che aveva due teste). Questa volta la spiegazione è semplice: per Elena Lappin l’autore è sincero perché possiede una doppia personalità. Jorge Semprún non è distante dall’esprimere lo stesso parere (Le Journal de Dimanche, Parigi, 6 febbraio 2000, pag. 27); ne approfitta per fare l’apologia della finzione che, dice lui, deve “dare il cambio” sempre di più alla storia. Egli dichiara testualmente: “Questo è già avvenuto nel cinema. Spielberg e Benigni hanno oltrepassato la realtà con la finzione, e si vede bene che questo funziona”. Ma si levano sempre più voci per denunciare il contributo involontario dell’autore allo sviluppo del revisionismo. Isabelle Rüf scrive: “Una simile impostura rende sospetti i racconti veridici e conforta i revisionisti che pullulano su Internet. Inoltre, Wilkomirski dà dell’ebreo “post-olocausto” l’immagine convenzionale e kitsch che serve alla classe da cui l’autore è uscito: piagnucolosa, lacrimosa, distrutta per sempre (Le Temps, Ginevra, 21 febbraio 2000, pag. 19)
La giustizia elvetica decide di risparmiare il “possibile” mitomane
Uno dopo l’altro gli editori ritirano, totalmente o in parte, il libro dal circuito commerciale. La giustizia zurighese entra in scena. Viene depositata una querela per frode. Nell’aprile del 2000 ha luogo una perquisizione al domicilio dell’interessato. Ma il 12 dicembre 2002 un dispaccio d’agenzia annuncia che il giudice dell’istruttoria ha deciso l’archiviazione dell’inchiesta sull’autore di false memorie su Auschwitz. Ecco il testo dell’Agenzia telegrafica svizzera:
Zurigo – Non si tratta di un impostore ma di un mitomane. Bruno Doesseker, alias Binjamin Wilkomirski, autore del libro Fragments, che racconta i ricordi di un bambino ebreo sopravvissuto al campo di Auschwitz, ma che in realtà è un falso, non sarà giudicato per truffa, né per concorrenza sleale. La giustizia zurighese ha appena archiviato l’inchiesta che era stata aperta a questo proposito. Le indagini hanno dimostrato che nessun elemento concreto permette di pensare che l’autore del libro abbia voluto nascondere la sua vera identità “in maniera fraudolenta”, scrive oggi il giudice istruttore Lucienne Fauqueux la quale, il 23 ottobre scorso, aveva deciso il non luogo a procedere. “Benché sia dimostrato che il libro contiene affermazioni false, non esistono delle prove che il suo autore abbia mentito”, ha dichiarato il giudice all’agenzia ATS. “È possibile che Doesseker/Wilkomirski sia stato realmente convinto della sua versione dei fatti, ma questo punto non attiene all’inchiesta”, ha aggiunto la signora Fauqueux.
Questa decisione giuridica avrebbe dovuto sollevare un sacco di commenti, invece, sembra essere stata seguita da un totale silenzio. Oggi l’affare Wilkomirski pare chiuso, con sollievo, non ne dubitiamo, di molti.
Quando “Verità non è difesa”
In materia di menzogna olocaustica, la giustizia elvetica, e lo si vede, non ragiona diversamente dalla giustizia francese, tedesca, austriaca, olandese, canadese od australiana. Essa appoggia la menzogna commessa in buona fede o anche la menzogna possibilmente commessa in buona fede. In Canada, ad esempio, le organizzazioni ebraiche, scottate dai successi revisionisti davanti ai tribunali regolari, hanno ottenuto la creazione di tribunali speciali chiamati “tribunali di commissioni dei diritti dell’uomo”. Davanti a questi tribunali, sprovvisti di una giuria, “Truth is no defence” (Verità non è difesa). L’imputato non ha qui il diritto di difendersi facendo valere il fatto che, se egli si è permesso quella affermazione che gli viene rimproverata, è perché, per lui, quest’affermazione è vera. Se mai vi si arrischia, lo stesso tribunale che gli ha appena fatto prestare il giuramento di “dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità” gli metterà davanti la nuova formula sacramentale, secondo la quale “Truth is no defence”. Questo tribunale non si preoccupa, in effetti, che di sapere se ciò che ha affermato l’accusato causi o meno un qualche danno, fosse anche psicologico, al querelante. Il giudice si fa allora spesso pesatore d’anime e d’intenzioni, il che apre la strada all’arbitrio. Si capirà dunque che un querelante ebreo avrà sempre buon gioco da far valere davanti a questi tribunali che, ad esempio, la contestazione revisionista dell’esistenza delle camere a gas nazisti gli toglie il sonno e gli causa dei danni psichici. Risparmiando Binjamin Wilkomirski, la giustizia elvetica non ha dunque fatto altro che seguire la corrente in materia di “Olocausto”; d’altronde essa non manca mai di proteggere la menzogna.
Lontano dal re degli impostori: Elie Wiesel
La mitomania è una tendenza morbosa a dire le menzogne, a favoleggiare, a simulare. Può aiutare a raggirare, a truffare, a rubare. Permette talvolta di raggiungere la gloria o di edificare una fortuna. Grosjean/Doesseker/Wilkomirski ha quindi conosciuto la fortuna e la gloria, seguite, nel suo caso, dalla decadenza. Il suo statuto di non-ebreo ha finito per danneggiarlo ma, d’altra parte, egli è uscito dall’affare a buon mercato poiché ha beneficiato dei privilegi che non si negano ai cantori della mitologia ebraica. Col beneficio del dubbio, un giudice istruttore gli ha permesso di tenersi il denaro che aveva acquisito disonestamente.
Sul piano delle invenzioni assurde, della scemenza sentimentale e della povertà d’espressione letteraria, Bruno Grosjean è andato lontano quanto l’autore del Diario di Anna Frank e, come quest’ultimo, ha finito per essere smascherato. Tuttavia Otto Heinrich Frank ha avuto appena il tempo di conoscere la vergogna, e poi, ciò va detto, gli ebrei, dopo la sua morte sopraggiunta nel 1980, hanno fatto molto scalpore e orchestrato una tale campagna di disinformazione che il grande pubblico è stato tenuto all’oscuro sulla scoperta della frode. Il Diario di Anna Frank prosegue dunque imperturbabilmente la sua brillante e fruttuosa carriera.
Sul piano della falsa testimonianza, Elie Wiesel, lui, continua ugualmente la sua corsa ampiamente in testa ai falsi testimoni di Auschwitz, ben innanzi a Martin Gray, Filip Müller, Rudolf Vrba, Mel Mermelstein, Abraham Bomba, Fania Fénelon e alla folla considerevole degli altri mitomani dell’ “Olocausto”. Non è detto che un giorno la sua gloria e la sua fortuna di Premio Nobel per la Pace non eguaglieranno quelle dei Rothschild.
Per ora, nel suo settore, Elie Wiesel resta il re degli impostori e, accanto a lui, siamo tutti d’accordo, il goy Bruno Grosjean fa una ben pallida figura.
22 dicembre 2002